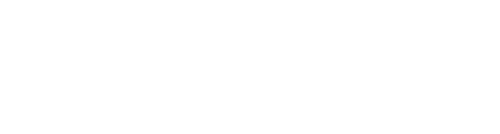Libri di Eduardo Simeone
La letteratura greca dell'antichità. Il periodo attico (480-320 a.C.)
Ulrich von Wilamowitz Moellendorff
Libro: Libro in brossura
editore: La Scuola di Pitagora
anno edizione: 2019
pagine: 185
Seguendo una prospettiva anticlassicistica cui si mantenne fedele dalla gioventù fino all’estrema vecchiaia, il grande Wilamowitz nella sua Letteratura greca dell’antichità dedica all’età classica (V e IV sec. a. C.), la più conosciuta e rinomata, soltanto una settantina di pagine su un totale di oltre 300. Ma le pagine che egli scrive su quello che chiama “periodo attico” sono all’altezza della fama che lo vuole tra i più grandi, se non il più grande, filologo classico di tutti i tempi. I ritratti che Wilamowitz traccia tra gli altri di Sofocle, di Euripide, di Isocrate, di Senofonte e di Platone mettono a fuoco le grandi personalità letterarie dell’epoca condensando magistralmente aspetti biografici, sfondo storico e valutazioni estetiche. Uno dei capitoli più interessanti e per certi versi sorprendenti di questa sezione della Letteratura greca è quello dedicato all’origine delle forme drammatiche. A oltre tre decenni di distanza dalla giovanile querelle che lo vide protagonista contro Friedrich Nietzsche, qui Wilamowitz – pur continuando a rivendicare la bontà e la necessità del cosiddetto metodo storico-critico – non esita a dichiarare che «tragedia e commedia, quelle diventate storicamente generi greci, hanno la medesima radice: l’estasi dionisiaca».
L'esistenzialismo di Omero
Karl Dienelt
Libro: Libro in brossura
editore: La Scuola di Pitagora
anno edizione: 2019
pagine: 26
Scritto nel 1951 in occasione della ricorrenza dei duecentocinquant'anni di un ginnasio viennese, e muovendo dal presupposto che la filologia classica - una scienza il cui oggetto sono le opere da cui ci separano più di duemila anni - debba giovarsi del contributo di altre discipline, Karl Dienelt, discepolo di Viktor Frankl, legge nei poemi di Omero un inaspettato esistenzialismo nell'accezione del noto fondatore della logoterapia. Da una parte ci sono gli dèi immortali, dall'altra gli eroi, mortali e consapevoli, come Achille, della propria fine. «La finitezza dell'uomo non costituisce un momento dell'essere che lo privi di significato, ma al contrario essa è basilare proprio per il significato dell'umana esistenza. "Nella limitatezza del tempo e dello spazio terreno l'uomo deve compiere qualcosa conscio sempre di essere mortale e tenendo ben presente la propria immancabile fine"».
Nel segno di Erasmo. Philologia perennis e identità culturale europea
Eduardo Simeone
Libro: Libro in brossura
editore: La Scuola di Pitagora
anno edizione: 2014
pagine: 178
A conclusione della sua Gedenkschrift su Rudolf Pfeiffer J. Latacz rammenta l'indole mite e pacata del filologo di Augusta: egli non fu né una personalità turbolenta e combattiva come Wilamowitz né uno spirito ipersensibile come K. Reinhardt, ma piuttosto uno di quegli 'àndres agatòi' che incarnano nell'accezione greca del termine la giusta misura e costituiscono i veri e propri custodi e garanti della philologia perennis. In questo senso si comprende il suo ricorso ad Erasmo, nume tutelare, guida spirituale e antidoto perenne alla barbarie di ieri, di oggi e di domani. È lui il simbolo di una filologia concepita come un sinolo di sentimento religioso, umanesimo e scienza critica che permane attraverso un "untergründig fliessende Strom der kulturellen Einheit europäischer Geschichte", di cui Pfeiffer è storicamente consapevole, che va dall'età di Callimaco, il primo Kulturbewahrer, al circolo degli Scipioni, poi fino alla Spätantike ed al Medioevo cristiano, quindi al Rinascimento e di lì al mondo moderno e contemporaneo.