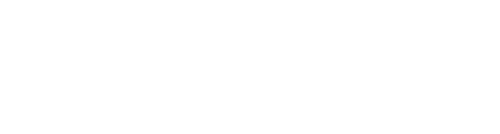Libri di Antonio Vito Boccia
La Basilicata federiciana nella toponimia medievale: rudimenti di storiografia sveva. Origini e aspetti pregiuridici del territorio
Antonio Vito Boccia
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 262
Con la struttura e con la forma di questo saggio, che ha ad oggetto uno studio sulla nascita dell'assetto moderno della Basilicata, viene presentata anche un'indagine approfondita sull'origine delle città lucano-basilicatesi e sulla determinazione dei confini della stessa regione, così come la conosciamo oggi. Nell'ambito di tali ricerche, finalizzate a ricostruire una storia che è ancora pressochè inedita, è stata messa in rilievo l'identità medievale del coronimo Basilicata, per come è risultato sia in base alle poche fonti primarie esistenti, che all'analisi toponimica: alla luce delle considerazioni contenute nel testo si vedrà che è lecito parlare di genesi 'sveva' della regione. Fermo restante il contenuto scientifico e il carattere argomentativo dell'opera, inoltre, vengono esposte una serie di tematiche di carattere storico-giuridico, unitamente ad altre di carattere linguistico, per quanto è possibile attraverso modalità divulgative. Sia le citazioni bibliografiche, sia quelle di archivio - se ritenute indispensabili - sono infatti presenti e vengono accennate ed inserite nel corpo del testo, mediante dei richiami volutamente sintetici (e non a piè pagina). Si deve poi segnalare il vasto utilizzo della 'toponimia', come principale metodo di ricerca: si tratta, com'è noto, di una scienza ausiliaria che risulta essere fondamentale per lo studio della storia del territorio, soprattutto in assenza di specifiche indagini archeologiche e di penuria archivistica. Essa, pur facendo parte della linguistica, intrattiene rapporti indispensabili con gli studi storici: infatti, riesce a rappresentare la significativa resistenza - sui luoghi - di veri e propri 'fossili linguistici', i quali possono fungere da guida, fornendo molto spesso adeguati e obiettivi riscontri, laddove (come nel periodo tardo antico e alto medievale) le fonti documentarie di primo grado sono molto scarse. A proposito di fonti d'archivio, dobbiamo ricordare che, perseguendo l'abitudine inveterata di cancellare una storia scomoda, fatta soprattutto di una presenza religiosa "concorrenziale" nel Mezzogiorno (parliamo di obbedienza 'ortodossa'), la chiesa cattolica - anche se involontariamente - ha grandemente contribuito a rendere poco leggibile l'epoca in esame, distruggendo il culto ortodosso e, vieppiù, i testi ad esso legati. A ciò si aggiunga la dispersione di una gran parte del patrimonio laico e, in particolare, di quello codicistico greco-medievale appartenente alla corte di Federico II, che venne improvvidamente donato da Carlo D'Angiò al papa e che, quindi, alla metà del Tredicesimo secolo fu trasportato in quello che sarebbe diventato l'archivio 'segreto' vaticano. Alcuni di questi codici si sono salvati e fanno parte del nucleo di partenza della raccolta vaticana, ma devono essere ritenuti come materiale archivistico disorganico e non perfettamente catalogato (inoltre, sono scarsamente studiati). Si specifica, infine, che pur non avendo una vocazione manualistica, il libro - grazie all'analisi di alcuni manoscritti medievali (soprattutto cronache e atti giuridici) - offre uno spaccato di storia del diritto vigente nel Mezzogiorno d'Italia, all'indomani dell'anno Mille.
Rudimenti di storiografia longobarda: il ducato di Napoli nella toponomastica
Antonio Vito Boccia, Gennaro De Crescenzo
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2024
pagine: 128
Dal punto di vista politico-istituzionale al duca spettavano compiti relativi agli aspetti militari e fiscali, al vescovo quelli relativi agli aspetti liturgici e quelli relativi alle strutture ecclesiastiche e ai monaci e alle monache quelli relativi all'assistenza, alla carità e alla organizzazione rurale alla base dell'economia del tempo. Di primo piano, allora, il ruolo del monachesimo locale che, attraverso i suoi enti di diverse dimensioni, gestiva un potere importante una volta decaduti gli ospedali municipali e "laici" fin dalla metà del V secolo. Anche in questo aspetto emerge una caratteristica che rappresenta forse un "unicum" tra le città del tempo: Napoli, pur nella sua autonomia rispetto a Bisanzio, operò una fusione tra la cultura greca delle sue radici e quella latina. Erano diverse e consistenti, del resto, le comunità ellenofone in tutta la Campania ed era diffuso dappertutto un senso di rispetto e ospitalità verso queste persone che richiamavano, per tanti aspetti, elementi dell'antica Magna Grecia. In questo senso pesava la consolidata tradizione dei traduttori presso gli Scriptoria napoletani e anche quella delle letture e dei canti in greco nelle cerimonie più solenni (uso presente solo a Roma a quel tempo) in un bilinguismo che conteneva implicazioni originali, articolate e affascinanti. Sorprende, come detto in precedenza, il mancato approfondimento di quello che alcuni studiosi hanno giustamente definito "particolarismo napoletano", un aspetto sinonimo di una dinamicità e di una originalità con pochi precedenti almeno in Italia. Tra altre fonti, la Cronaca di Partenope sostiene la tesi delle sei chiese greche presenti in città e si registra anche una singolare tradizione: la mattina del sabato santo, i primiceri/responsabili di queste chiese erano tenuti a recarsi al duomo per cantare o leggere sei lezioni greche e, a Pasqua, assistere il Cimiliarca (ministro di culto) e cantare il Credo in lingua greca e secondo il rito dei Greci con la riproduzione di alcuni atti comici o facezie dette in latino volgare "squarastase". Napoli fu capace, così, di diventare e restare un simbolo della grecità ma una grecità letta, vissuta e realizzata attraverso la latinità con la creazione di nuovi modelli istituzionali, liturgici, linguistici e politici. In questo rivestirono una grande importanza le scelte "autonomistiche" e accentratrici da parte dei duchi, forti di un senso di appartenenza di grande rilievo culturale. E questo discorso si lega profondamente ai fattori locali "identitari" che spesso vengono richiamati (in qualche caso per condannarli o per negarli) anche in tempi recenti. Napoli, allora, come capitale culturale e, in seguito, politica di un intero territorio destinato, nei secoli, ad espandere i suoi confini ben oltre quelli della "città-stato-signoria" ducale. La storia del ducato, allora, diventa paradigmatica e anche coerente con la storia di una identità che parte dalle radici greche, passa per quelle latine e diventa, poi, tra i Normanni e i Borbone, la base di una "nazione napoletana" che spesso ancora oggi fornisce spunti per dibattiti vivaci e utili. Perciò ci pare molto significativo un documento nel quale il duca Sergio IV concede diversi beni e privilegi al monastero di San Gregorio «affinché le Sacre Vergini potessero pregare per i loro donatori e per la salute della patria». Questo testo intende rappresentare un primo tentativo di ricostruzione complessiva dell'ormai dimenticato periodo alto-medievale, vissuto dalla città di Napoli. Forse per le obiettive difficoltà di reperire fonti, noi oggi ci troviamo di fronte a un autentico paradosso: conosciamo di fatti la storia della Napoli greca e di quella romana, ma sul cosiddetto "ducato di Napoli" (definizione che utilizzeremo solo per esigenze di sintesi e semplificazione) - peraltro un periodo complesso e lungo oltre seicento anni (VI-XII secolo) - le ricerche e gli approfondimenti sono sempre stati limitatissimi.
Il ducato e Napoli medievale, le origini di una grande capitale
Antonio Vito Boccia, Gennaro De Crescenzo
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2024
pagine: 128
Questo testo intende rappresentare un primo tentativo di ricostruzione complessiva dell'ormai dimenticato periodo alto-medievale, vissuto dalla città di Napoli. Forse per le obiettive difficoltà di reperire fonti, noi oggi ci troviamo di fronte a un autentico paradosso: conosciamo di fatti la storia della Napoli greca e di quella romana, ma sul cosiddetto "ducato di Napoli" (definizione che utilizzeremo solo per esigenze di sintesi e semplificazione) - peraltro un periodo complesso e lungo oltre seicento anni (VI-XII secolo) - le ricerche e gli approfondimenti sono sempre stati limitatissimi. Ad esempio, se nel passato (magari per la storia della Napoli borbonica) la storiografia ha spesso utilizzato la categoria della "damnatio memoriae", per quella del ducato napoletano sono molto evidenti alcuni elementi ulteriori, come la scarsa presenza di fonti documentarie di secondo grado, unita all'assenza quasi totale di tracce archivistiche (scarsissime quelle archeologiche). Se non deriva da tali obiettive difficoltà, la curiosa dimenticanza di un periodo storico così importante potrebbe essere conseguenza di una precisa scelta… Tutto questo potrebbe essere legato ad una scelta, prima culturale e poi sostanzialmente politica: è qui che si inserisce quel dibattito che si accese, all'indomani dell'unificazione italiana, fra i sostenitori di una cultura italiana e internazionale, e quelli che sostenevano, invece, la necessità di una cultura ancora "napoletana" (nel senso più ampio del termine, associandola cioè all'idea di una nazione napoletana/meridionale). Da un lato, in realtà, c'erano l'identità, le radici e l'orgoglio: con una storia che partiva dalle remote origini greche della città che, con una sua continuità e una sua coerenza, arrivava fino ai Borbone; e, dall'altro, le tesi post unitarie di chi riteneva inutile, dannoso e superato lo studio di quel percorso, per fare spazio a nuove storie, a nuove radici e nuove identità.
La difesa del synoro tra Kalabria e Loukania
Antonio Vito Boccia
Libro: Copertina morbida
editore: Pellegrini
anno edizione: 2021
pagine: 231
Attraverso una ricostruzione innovativa e sostanzialmente linguistica il saggio analizza la struttura complessa di un limes bizantino: il cosiddetto Synoro, un istmo che mette in connessione le sponde tirrenico-ioniche. L'autore, per descrivere l'unicità di tale territorio, supplisce alla mancanza di fonti documentarie ed epigrafiche sia attraverso il ricorso ad alcune agiografie che con l'analisi di numerosi toponimi. Ed è proprio il sapiente dosaggio di tale materiale a restituirci un suggestivo affresco del camminamento sinnico e dei suoi insediamenti durante l'epoca alto medievale: più una cerniera che una autentica frontiera, un'insula di cultura greca adagiata tra l'odierna Basilicata e la penisola calabrese - mai conquistata dai popoli germanici - dove i rhomaioi si sono insediati dal 540 al 1080. La suddetta area, in posizione strategica per Costantinopoli, era stata devastata dalla guerra gotica: per questo essa venne in primis frequentata dai cosiddetti monaci "basiliani", e poi preservata militarmente dai limitanei bizantini, mediante un imponente sistema difensivo edificato prima del Nono secolo: a partire da quell'epoca le truppe imperiali occuparono definitivamente l'istmo, controllandone gli itinerari viari e gli scali marittimi, ripopolandolo e favorendone lo sviluppo economico. Il Synoro fu realizzato con il kastellion di Tursi, unitamente ad un porto militare posto nel golfo di Taranto, con torri e kastra di dimensioni minori sorti lungo il fiume, e con il kastellion di Lauria, a sua volta munito di un porto ubicato nel Golfo di Policastro: un vero e proprio antemurale, che servì a tutelare la Calabria bizantina da possibili invasioni dei longobardi, il popolo guerriero stanziatosi nei Principati di Benevento e Salerno che curiosamente rimaneva immune dalle varie pestilenze che colpivano l'Italya. Grazie alla narrazione di vicende mai indagate e ad avvenimenti storici mai approfonditi il lettore potrà riconoscere la particolare morfologia di quest'antica area geografica e sociale, nonostante l'incuria abbia contribuito a disperdere i resti dei kastra e delle torri e a occultarne le tracce: si tratta insomma di un'immagine suggestiva di quel tempo lontano, che ci permette di guardare alla storia del Mezzogiorno con occhi diversi.
Un'eredità del Synoro bizantino: il giustizierato normanno del Sinni
Antonio Vito Boccia
Libro: Libro rilegato
editore: Autopubblicato
anno edizione: 2023
pagine: 62
L'antico limes bizantino edificato sul fiume Sinni attorno al decimo secolo per frenare l'avanzata dei longobardi diventa un giustizierato, con l'arrivo dei normanni. Perciò tutta l'area sinnica posta a confine tra Basilicata e Calabria entra a far parte del nuovo istituto giuridico, pur conservando le sue antiche caratteristiche di grecità.