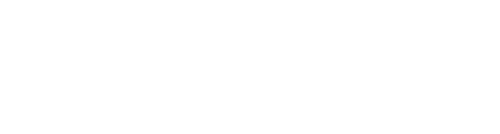ABE
Atripalda, come eravamo: genealogia, cognomi e toponomastica di 300 anni fa nell'ex «Civitate Avellino» capoluogo della nuova Irpinia
Sabato Cuttrera
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 132
A partire dalla Rubrica I. del Catasto Onciario, come segue, il lettore troverà in ordine alfabetico, per nome di capofamiglia (compresi i pochi toponimi che inizialmente si presentavano illeggibili), i fuochi con l'età di ogni singolo componente dalla seconda metà del Settecento. Poi, in ordine progressivo, le chiese, le vedove, i forestieri, etc (II, III...). Questo sistema permetterà, a chi volesse approfondire le notizie relative alla propria casata, di individuare nell'immediato tutti coloro che portano il proprio cognome (senza trascurare di visionare la lettera "d" per gli apostrofati avulsi) e di risalire subito alla data di nascita di ogni abitante. Si tratta della bobina n.4557, conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli, da cui il gruppo di studio ha tratto le schede su cui si basa questo lavoro. In ogni scheda sono stati riportati i dati trascritti nell'appendice che segue. Atripalda appare un po' come i quartieri di Caserta, fatta esclusione di Torre, dove vivono comodamente quelli che possiedono un vero palazzo e quelli che si trovano citati nelle varianti del Catasto capuano col titolo di nobili viventi che vivono di entrate o annue entrate. Per il resto sono quasi tutti braccianti. In pochi rappresentano la figura del ricco che vive nobilmente, altrimenti detto nobile cittadino o nobile uomo, distinguibile dalla massa perché vive del suo. Uomini nobili che diventano magnifici appena entrano nell'amministrazione della Cosa pubblica dell'Università comunale per vivere civilmente, cioè di rendita. Il Catasto di Atripalda tende alla chiarezza e non è difficile, sebbene sia complesso, leggerlo in ogni sua parte, perfino nelle sottili sfumature che ci hanno portato toponimi ormai in disuso e ad interpretare tutti quelli punteggiati com l'Att.° per attuario. Talvolta ciò è accaduto anche per i nomi propri, come nel caso di Agnese, Caterina, Salvatore, Giuseppe, Giovanni, Giovannibattista, Biagio e Tommaso, lasciati nella versione di Agnesa, Catarina, Salvadore, Gioseppe, Gio:, Gio.batta, Tomase e Biase. Non per questo si sono evitati sempre errori, sebbene con nomi del tipo Marzia o Mattia; in alcuni casi, è davvero difficile capire se si tratti di un maschio o di una femmina per la sottile differenza fra r e t del compilatore, di una F o di una T nella forma originale. Oppure di Catarina così trascritta. Alla D. è stato quasi sempre eliminata la punteggiatura trascrivendo direttamente il Don o Donna onde evitare equivoci. Idem con la N.ro del Notaro, o nel caso dei Priv., ove si è sempre inteso privilegiati, come per il M.°, indicato per magnifico nel caso di un ricco, oppure per mastro se si è trattato di un artigiano e terminava in ro, cioè M.ro seguito dalla relativa specifica, così per Sac. oppure S. divenuto direttamente sacerdote.
Vico Equense dalla A alla Z: Abecedari di genealogia e toponomastica con tutti i nomi degli abitanti dal 1700 al 1900 del comune della Costiera Sorrentina di Sorrento (Na)
Sabato Cuttrera
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 238
Vico risulta abitata da forestieri bonatenenti che posseggono il maggior numero di terre, a cominciare dal Casale di Bonea e la chiesa parrocchiale di S.Giovanni Evangelista, detta di S.Maria Visita Poveri. Attualmente il territorio comprende 14 frazioni rappresentate da nuovi e vecchi Casali: Arola, Bonea, Fornacelle, Pietrapiano, Massaquano, Moiano, Montechiaro, Pacognano, Preazzano, Santa Maria del Castello, Sant'Andrea, Patierno, Seiano e Ticciano, Monte Faito. Quasi trecento anni fa, come vedremo, le cose stavano un po' diversamente. Il Casale di Bonea, per esempio, è uno dei più antichi casali di Vico costruito intorno alla sua Chiesa Parrocchiale di S.Giovanni Evangelista, ufficialmente definita venerabile Chiesa di San Giovanni Evangelista, sita nella piccola piazzetta a cui gli abitanti hanno dato il nome più comune di Santa Maria Visita Poveri per la devozione a quella madonna, riedificata più a monte dopo l'alluvione del 1700. Il Casale di Bonea si ritrovò ad essere abitato soprattutto da ecclesiastici. Anzi, si può dire, che erano i religiosi a formare il Casale. Gli ecclesiastici del Casale di Bonea, compreso il Reverendo Sacerdote Canonico Don Giuseppe Celentano, erano 15, e tutti, ovviamente con il titolo di Reverendo Sacerdote. Si tratta di: Don Alesio Buonocore, Don Cesare Cioffi, Don Carmine Balzamo, Don Ciro Parascandalo, Don Ciro Framola, Don Gennaro Gargiulo, Don Giovanni Casentino, Don Giuseppe Mariano, Don Giuseppe Balsa, Don Giuseppe Storace, Don Mattia Storace, Don Erasmo Parascandalo, Don Lorenzo Cosenza, Don Luca Manganaro. Pochi altri, oltre i religiosi, erano gli abitanti del casale. Si contano dieci famiglie possidenti, tutte forestiere, fra cui primeggiano il Magnifico Bruno Ramagnino di Calabria e i 4 privilegiati: il privilegiato marinaro Giuseppe Cosenza di Napoli, il privilegiato marinaro Gioacchino Visco di Napoli, il privilegiato Nicola Attanasio di Napoli e il privilegiato bracciale Pietro Esposito di Napoli. Ad essi vanno ad aggiungersi il marinaro dell'A.G.P. Salvatore Esposito di Napoli e il marinaro dell'A.G.P. Vincenzo Esposito di Napoli. Terminano la lista il bracciale Pietro Savarese di Napoli, lo scarparo Antonio Parascandalo di Napoli e Pietro Gargiulo di Napoli. Insomma sono solo i primi abitanti che si ritrovano sfogliando questo manuale vero e proprio che ne contiene migliaia...
Il monte dei maritaggi. Atti di notai. La dote e altri documenti ultra principato di Avellino
Sabato Cuttrera
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 112
All'epoca le vergini venivano collacate in matrimonio con lo sposo dalla famiglia con promessa di consegna della dote valutata in ducati. Per Olimpia Iacenna nel 1726, il padre e la madre consegnarono al marito Natale Matarazzo di Avellino una dote di 130 ducati, cioè docati venti di panni di lino, lana, ed oro lavorato, e poi docati centodieci sine fu assegnata una casa di tre stanze, con orto e largo avanti nel Casale della Valle di Mercogliano. Prima di dare concedere la mano di una figlia, il genitore era tenuto a preparare la nota delli panni di sposa, cioè la dote della vergine. Questo accadeva per Pietrastornina, paese situato a monte della Valle di Benevento. In un atto del 1735 del notaio Ragucci è accluso un appunto del padre di Nicoletta Salvi che dà la figlia in moglie a Francesco Lambiasi di Napoli, scrivendo un breve memorandum della dote. Egli fa una nota delle robbe che si porta Nicoletta mia figlia in Napoli per il suo matrimonio col Signor Francesco Lambiasi elencando un vestito con struscio giallo nuovo, altro vestito sottanetto di damasco rosso di color amaranto nuovo, un busto di pioppo ricamato novegno, una toleschina di damasco, un drappo ricamato per un copertino, sei camiscie, quattro maccatora bianche nuove, e due altra di velo di seta usate. L'uomo beneventano vestiva in modo semplice, con pantalone e camicia bianca; la donna con abito scarlatto con fregi ai polsi. Fin dal 1674, sul Partenio, si conosceva anche il secreto del Signor Principe della Pietra Sturnina acciò partorisca subito una donna, fu svelato solo nel 1674. Fu tramandato dal notaio Gaita di Montefusco alle popolazioni della Montagna. Egli stesso suggerisce: se scrive il seguente; et potendosile la donna inghiuttire sarebbe meglio, ò vero si la lega così la donna, et vi la ponghi sopra del ventre che partorirà; et a Deus. Questa la filastrocca da recitare al momento opportuno: Anna peperit Mariam, Maria peperit Salvearem creature exi foras, quia Christy te vocat, Christy veghat, Christy venit, Christi imperat, Christi xe ab omni molo defendat. Ma il notaio aveva sperimentato anche un rimedio contro il freddo, quello che stavolta chiama secreto per la quartena Deus. Bastava bere un ottimo bicchiere di vino greco con della polvere di ventricello di gallina essiccato. Se l'esperimento falliva una prima e seconda volta lo si poteva ripetere una terza volta che sicuramente sarebbe riuscito. Garantito dal notaio Giordano di Montefusco: - Dal ventre della gallina la pelle di dentro lo ventricello si secca, et si ne fà polve pestata, et poi se ne dà quanto copre un' tre cavalli al patiente dentro d'un bicchiero di greco perfetto, et si la dà all'hora quando il patiente sa conosce che sta per venire il freddo seu patere; et sì conoscendo che habbia colpito alla prima; seguiti per tre volte, è exeperimentato. I costumi ufficiali maschili sono rappresentati dall'uomo in pantalone e camicia bianca e dalla donna in abito lungo scarlatto con fregi ai polsi dello stesso tessuto, seta o anche d'argento. Presumibilmente si tratta quindi di una gonnella di panno scarlatto tagliato a guisa di toga o stola fino al tallone e lavorata a mano. E' ornata nel lembo da varie fasce sempre di scarlatto o vellutino in seta uguale o diverso da quello della toga. Le cuciture delle maniche sarebbero quindi ornate di liste di scarlattino o vellutino forse ad interlaccio che può ornare anche il busto. Il caso dell'argento è forse propriamente della chiusura della pettina, così come in alcuni usi, con bottoni d'argento o lacci di seta. L'abito a gonnella si completerebbe quindi, nella parte sottostante, con la vera tunica senza maniche, una sorta di casacca, mentre le gambe, a questo punto, sarebbero coperte da calzette ricamate in seta con ai piedi i classici pianelli ma anch'essi ricamati. Non resta che rovistare nelle soffitte alla ricerca della veste scarlatta.
Cervinara dalla A alla Z. Abecedari di genealogia e toponomastica con tutti i nomi degli abitanti dal 1700 al 1900 del comune della Valle Caudina (Av)
Libro: Libro in brossura
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 354
Molte le mini industrie artigianali di fine ottocento, come quelle rappresentata da Salvatore Cioffi di Pasquale e da altri negozianti vari. Ma vediamo nei particolari gli abitanti di Cervinara che esercitavano arti e professioni. Negozianti di cereali erano Pietrantonio e Raffaele Cioffi fu Sigismondo, Onofrio Cioffi fu Lorenzo, Andrea Caporaso fu Saverio, Raffaele Cioffi fu Domenico, Isidoro e Giuseppe Cioffi di Onofrio, Michele de Dona fu Orazio, Marco de Dona fu Giovanni, Francesco Lanzillo fu Antonio, Antonio Lanzillo fu Francesco e Pasquale Pitaniello fu Carmine. Facevano parte della categoria dei negozianti di stoffe Antonio e Giacomo Cincotti fu Giuseppe. Negozianti di vino (venduto anche nella cantina di Antonio Cantone fu Pietro) erano Raffaele Milanese fu Angelandrea e Saverio Marro fu Pietro; la neve, pigiata a ghiaccio nelle fosse montane, era invece una specialità di Pasquale Clemente fu Domenico che, dopo averla nascosta sotto le foglie per tutto l'inverno, aspettava i giorni più caldi per rivenderla ai caffè e alle gelaterie del napoletano, oltre che a quelle della Valle Caudina e alla caffetteria cervinarese di Felice Cincotti fu Giuseppe; il sensale autorizzato per situazioni varie era Giuseppe Cioffi fu Domenico. Diversi i negozianti di legnami, come Filippo Ceccarelli fu Michele e Fortunato Ceccarelli fu Felice che, dopo aver disboscato le montagne lavoravano il legno in maniera artigianale; ricordiamo anche altri venditori come Pasquale Cioffi fu Gregorio, Luciano De Maria fu Felice, Pasquale Fierro fu Giuseppe, francesco Iglio fu Angelo, Pasquale Miele fu Carmine, Giovanni Pagnozzi fu Antonio e Luigi Ricci fu Arcangelo. Tanti volti, tante storie, tanti mestieri, come l'appaltatore di opere di fabbrica Antonio Bianco fu Stefano, il negozio di formaggi di Andrea Taddeo fu Domenico e l'industria agraria di Nicola Tangredi di Giuseppe. Altre aziende agricole erano quelle di Giovanni de Gregorio fu Vincenzo, Luigi Lengua fu Nicola, Luigi, Nicola e Pasquale Marchese fu Gennaro, Luigi Iacchetta fu Giuseppe, Orazio e Gennaro d'Onofrio fu Giovanni, Stefano Casale di Giuseppe, Raffaele Niro fu Domenico. Sono solo alcuni degli esempi di quanti nomi, luoghi, chiese e quant'altro sia contenuto in questo affascinante viaggio nel tempo in Valle Caudina.
Annuario della canzone napoletana. Inizio Novecento. Volume Vol. 4
Antonio Sciotti
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 160
Il focus sulla canzone-attualità, genere che permette il primo lancio della ancora sconosciuta melodia partenopea erroneamente confusa con la canzone d'occasione e l'identificazione dei misteriosi primi interpreti napoletani e stranieri delle cosiddette canzoni internazionali (quali Voce 'e notte, Era de maggio, Tu ca nun chiagne, Reginella, Torna a Surriento, 'O sole mio, Santa Lucia luntana, 'O marenariello, Palomma 'e notte, Torna maggio, Maria Marì e altre) compensa un vuoto storico che meritava approfondimenti necessari. Viene tributato, inoltre, un posto d'onore agli investimenti stranieri, quello tedesco risalente al 1911 (Polyphon) e quello americano del 1923 (Santa Lucia), che rivelano non solo la capacità attrattiva della canzone napoletana, ma anche le diatribe derivanti da queste operazioni con rappresaglie da parte degli autori, editori e impresari. L'ultimo paragrafo funge quasi da intruso rispetto all'excursus temporale in oggetto ed è quello nel quale si accenna brevemente ai primi anni '90 del Novecento a completamento del quadro storico della canzone napoletana. E', questa, la IV parte dell'Annuario: 1910-1919. Gli Annuari di Sciotti, cioè la storia della canzone napoletana anno per anno, riuniti in volumi per decenni, rappresentano non solo la cronaca, il diario, di ciò che avvenne senza manipolazioni di sorta, perché i fatti, i dati, le foto, le tabelle, i ritratti, sono tutti estratti dai giornali dell'epoca. Ecco perché essi contengono anche pagine di storia della Napoli che fu, a volte sconosciuti, poco trattati o del tutto dimenticati che Antonio Sciotti, massimo storico della canzone napoletana, pubblica da decenni solo per Arturo Bascetta Editore.
Ricchi e poveri di Avellino città. Volume Vol. 3
Arturo Bascetta
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 148
A quei tempi, la buonissima pasta fatta in casa, prendeva soprattutto la strada della città e quella che restava era smerciata a Napoli e a Salerno nei giorni di festa. La maggior parte della pasta di cui abbiamo notizia si produceva ad Avellino in quanto era destinata a Piazza Della Libertà: alla cucina dell'Hotel Centrale di Galasso e al ristorante Della Sirena di Domenico Cristiano. Più di una erano le trattorie frequentate anche dai forestieri come Giardini d'Inverno di Domenico Nevola a via Clausura e quelle di Generoso Tino e Generoso Cucciniello in via Beneventana. La lista continua con Stanislao Festa in via Luigi Amabile, Antonio Carulli in via della Sapienza, Giuseppe Coppola a piazza Garibaldi, Nicola Cerulli al Corso. Per finire con la Trattoria del Genio in via Trinità e il ristorante Del Barone di Generoso Rosapane in via Costantinopoli, ma tante erano le massaie che appendevano alle canne le tagliatelle o appoggiavano i vassoi con gli gnocchi appena lavorati a quattro dita per lasciarli asciugare al sole. Nella realtà Avellino aveva continuato a essere una città laboriosa solo dal punto di vista intellettuale dopo la nascita del Real Collegio nel 1831, divenuto poi Liceo Colletta, dove si insegnavano le lingue e la letteratura, togliendo alunni allo stesso Seminario Diocesano. Non bisognava per forza diventare preti, insomma, per studiare. E così gli insegnanti Angelo Antonio Minichiello, Francesco Saverio Iandoli, Antonio Salomone, l'arciprete Bianco, Raffaele Masi, Michele Farina, Michele Palumbo, Tommaso De Stefano, Sabino Belli, Vincenzo Laudonia, Agnello Cocchia e Modestino Ottaviano crearono le basi ai futuri politici. Gli stessi professori del Seminario presero poi a insegnare ai ragazzi del Collegio, come Enrico Capozzi, Serafino Soldi, Nicola Abate, Carlo Donatelli, Nicola Amilcare Imbimbo divenuti poi quasi tutti avvocati. La notizia dell'apertura della scuola reale fu data alla Provincia il 10 ottobre del 1831 dalla Commissione Provinciale costituita dall'arcidiacono Francesco Saverio Jepparelli, dal dottor Fiorentino Zigarelli e dal canonico Antonio Preziosi; l'inaugurazione, per orazione pronunziata dal sacerdote di Fontanarosa, Tommaso De Rosa, avvenne il 1° dicembre tra professori e intellettuali famosi giunti in città a celebrare lo storico evento. Primo rettore del Collegio ne fu proprio, per dieci anni, don Tommaso De Rosa Piscitelli. Ne presero poi il comando Dulcetti e Imparati fino al 1853, quando l'istituto sarà affidato ai Padri delle Scuole Pie o Scolopi, direzione che esercitata da veri e propri padri-padrone. In successione, furono tra gli altri rettori del Liceo: Luigi Caputi, Carlo David di Ospedaletto, Antonio Noja, Giuseppe Lumello, Luigi Palmieri, Luciano Loparco, Martino Giannattasio, Federico Villani, Sebastinao Maturi, Vincenzo Cannaviello, Nicola Valdimiro Testa, Vittorio Bettei, Ferdinando Sasso, Gio: Battista Griseri, Teodoro Bosio, Francesco Giovannini, Emilio Sauté. Il Real Collegio divenne una scuola importantissima specie sotto la guida del prestigioso professor Basilio Puoti, appositamente giunto da Napoli su richiesta dei rettori del Collegio che, dal 1857, sarebbe stato elevato a Liceo con un numero maggiore di alunni e di cattedre, fino a diventare nel 1861 Real Liceo Ginnasiale e Convitto Nazionale col decreto di Vittorio Emanuele che toglierà definitivamente la direzione amministrativa dei Licei agli ordini religiosi. La prima ventata i ricostruzione del Regno del 1848 non interruppe quel ciclo, ma solo 225 furono gli avellinesi che sottoscrissero il documento di fedeltà a Ferdinando II, alcuni anche mezzi liberali. Il nuovo intendente Paolo Emilio Imbriani seppe mantenere l'ordine ricordando i moti liberali del 1821, nonostante il vescovo della città Maniscalco si fosse recato a Caserta a rendere omaggio al Borbone.
De Sanctis Francesco da Morra Irpina: lettere edite e inedite. Volume Vol. 2
Fausto Baldassarre
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 148
«I funerali di Francesco De Sanctis si svolsero in Napoli, il 4 gennaio 1883… Il carro funebre era tirato da dieci cavalli bardati, portanti ognuno sulla gualdrappa la stella d'Italia: il cocchiere e i palafrenieri avevano le coccarde di colori abrunate. La bara era ornata di ghirlande e corone tra cui alcune simboleggiavano la Camera, il Senato ed i principali municipi d'Italia… Il funerale di De Sanctis rappresentò per l'Italia un lutto nazionale, ma per Napoli fu un evento solenne, grandioso, eccezionale… Ma il saluto più simpatico, più affettuoso, più travolgente a Francesco De Sanctis lo die' l'anima di Napoli che avvertì col suo popolaresco, ma sicuro intuito, che non s'era spenta solo una fulgida luce intellettuale, ma era venuto meno un gran cuore, sicuro e schietto, aperto a tutti i palpiti, a tutti gli entusiasmi. Il povero Don Vito [dal quale noi carissimo figlio discendiamo], fratello del defunto, piombato da Morra a Napoli per rappresentare in qualche modo la famiglia d'origine, guardava (mi diceva Benedetto Croce) attonito e stupefatto la fiumana popolaresca, il mareggiare delle corone e delle insegne, dei vessilli e dei gagliardetti, e ripeteva trasecolato: 'Vi' che t'ha saputo fa' Ciccillo'… La frase di Don Vito sarebbe piaciuta al De Sanctis assai più del librone e della tomba che lo scultore Belliazzi gli approntò, con quella manierata freddezza che era nello stile del tempo, nel recinto degli uomini illustri a Poggioreale». Questa è la narrazione di Edmondo Cione. E' proprio vero che la morte svela la vita. Francesco De Sanctis è il mio compagno di viaggio. Segreta guida. Conforto. Il suo grande dolore, la sua resistenza: mai la resa. La sua forza è gioia di vita. Meraviglioso: quel guardare il cielo, quel saper vedere dentro, fuori e lontano. Caro Francesco ha lasciato in me luminose tracce. Con questo libro ho cercato di liberare il Nostro dai paroloni dei 'dottoroni' da ciò che il critico di Morra ha sempre combattuto. A tal proposito ricordo l'indignazione di zio Paolo De Sanctis, fratello di mia nonna, che nell'ascoltare i comizi dei politici di turno contestava il De Sanctis ideologizzato. Il Nostro antenato è straordinaria testimonianza di vita, di speranza. Ha conosciuto la notte oscura del carcere, la solitudine dell'esilio, non si è lasciato però travolgere dalla disperazione. L'esperienza del dolore gli ha dato sempre più forza. Ha lottato contro l'aridità e la desertificazione delle emozioni. Questo libro, caro Francesco, nasce dall'amore paterno. Tu, studente, in dialogo immaginario con l'antenato. Un dialogo che tocca con passione, essenzialità, chiarezza i temi della vita, dell'arte, della politica. Ricordo: avevo dieci anni. Indossavo il vestito della prima comunione. Con la littorina nella stazione di Montefalcione raggiunsi Morra. Linea ferroviaria Rocchetta S.Antonio, voluta dallo stesso De Sanctis. Mio padre mi affidò all'amico ferroviere. E suvvia!, inizia il mio viaggio. I miei occhi di bambino andavano man mano scoprendo la verde Irpinia, la nuova luce di Morra, tutti i luoghi desanctisiani, la sua casa, il focolare domestico, la culla di ferro, dove sono nati i nostri antenati. Custode di memorie mia madre. Zio Mimì: quest'ultimo straordinario narratore, capace di sintesi fulminanti. Di nonna Teresa Francesca De Sanctis ho un vago ricordo. Austera, vestita di nero sulla soglia della casa mi guardava dall'alto. Così la ricorda l'immaginetta: 'visse fra i riflessi del genio'. Figlio, scorrendo l'albero genealogico, vediamo che noi discendiamo dal fratello di De Sanctis, Vito (1824-1889), dal figlio Carlo (1854-1952) e dalla nonna Maria Francesca (1884-1954). Vito seguì il generale Pepe a Venezia e dopo l'impresa per diverso tempo fu in prigione a Brindisi e il fratello Francesco lo soccorse inviandogli sei ducati al mese. Ma l'aiuto è soprattutto spirituale.
Piedigrottissima in televisione (1957–1973). Storia internazionale della canzone italiana. Volume Vol. 2
Antonio Sciotti
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 128
L'idea dello spettacolo nasce dopo le movimentate vicende dell'ultimo Festival della Canzone Napoletana tenutosi nel mese di maggio. Infatti, in seguito alle accese controversie nate con la Rai si è tentato di risolvere il problema della radiodiffusione della canzone napoletana proprio con l'istituzione della Piedigrottissima. In altre parole, le polemiche nascono dal fatto che la canzone napoletana scritta da autori partenopei è ghettizzata a favore della canzone dialettale scritta da autori settentrionali. Alle forti accuse, la Rai si è sentita obbligata a rivedere il suo programma di radiodiffusione ed ha effettivamente accertato che su 600 canzoni napoletane trasmesse nel 1956, soltanto 64 sono quelle scritte e musicate da autori partenopei. Da questa polemica, Renato Barendson in collaborazione con Pino Bianchi, presidente dell'Associazione Canzoni di Napoli, lancia l'idea alla Rai di pareggiare i conti istituendo la Piedigrottissima, ovvero uno spettacolo che permetta la radiodiffusione di canzoni napoletane piedigrottesche scritte, con schietto spirito partenopeo, da autori nati nella città canora. Così, per la realizzazione di questo spettacolo, l'E.P.T. si rivolge agli editori partenopei che, grazie alle audizioni di Piedigrotta, tengono sotto contratto i più rinomati autori napoletani. Inizialmente aderiscono al progetto ben nove case editrici, poi ridotte a sette per due forfait. Da questa richiesta, la Direzione Generale della Rai organizza innanzitutto il programma radiofonico Piedigrotta Napoletana 1957 da trasmettere sul secondo canale, per il lancio di 27 canzoni, 3 per ogni casa editrice organizzatrice di spettacoli di Piedigrotta, a scelta della casa stessa. Il programma viene replicato ben 15 volte, in modo da assicurare un lancio sufficiente all'affermazione delle canzoni. Parallelamente a tutto ciò, Renato Barendson, oltre alla rubrica radiofonica, chiede alla Rai pure lo spettacolo televisivo Piedigrottissima che raccoglierebbe il meglio della nuova produzione piedigrottesca e che, grazie alla tv, si creerebbe un nuovo efficace strumento per la valorizzazione e la diffusione della canzone napoletana. Il presidente comunica alla Direzione Generale che di questo spettacolo provvederebbero per la produzione e l'organizzazione le stesse case editrici, eventualmente attraverso il contributo dell'E.P.T. La direzione della Rai in un primo momento esclude che la Piedigrottissima televisiva potesse rientrare nel piano economico ed artistico della produzione prevista fino a settembre. Poi, considerando che avrebbe dovuto soltanto mettere a disposizione le telecamere e il proprio personale per la ripresa, mette al vaglio anche la possibilità di una ripresa televisiva. Alla fine, cedendo alle pressioni, viene programmata la prima rassegna televisiva dedicata a Piedigrotta. Lo spettacolo di Piedigrottissima nasce per iniziativa di Renato Barendson, presidente dell'Ente Provinciale del Turismo (E.P.T.) che, rivalutando la festa di Piedigrotta dal punto di vista turistico, si sofferma sull'importanza della valorizzazione e diffusione delle nuove canzoni napoletane su scala nazionale. Per questo motivo, in collaborazione con la Rai, patrocina la Piedigrottissima, ossia la presentazione a un pubblico nazionale delle più belle canzoni di Piedigrotta. L'Ente, per raggiungere lo scopo prefissato, chiede il supporto delle sette più importanti case editrici del momento (Acampora, Argoss, Bideri, La Canzonetta, Cioffi, Giba, Di Gianni) che, durante il corso della festa di Piedigrotta, hanno presentato le loro nuove produzioni.
Il festival di Piedigrotta (1890-2010). Storia internazionale della canzone italiana. Volume Vol. 3
Antonio Sciotti
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 190
Questo nuova formula di spettacolo piedigrottesco va a sostituire, in maniera graduale, ma in meno di un lustro, il Festival di Piedigrotta. Si perde, così, l'agonismo della gara canora ma aumentano vertiginosamente gli interessi economici, in quanto le edizioni musicali con l'audizione impongono al pubblico in maniera più immediata le proprie canzoni che fruttano grossi guadagni sia alle case editrici che agli stessi autori, i cui contratti (spesso di esclusiva) frequentemente registrano notevoli cifre. La prima audizione viene presentata nel 1900 dall'editore Peppino Santojanni e, in meno di una decade, viene imitato dagli altri editori. Le imprese teatrali e gli impresari, con l'avvento delle audizioni, sono scoraggiati ad organizzare un festival perché viene a mancare la materia prima: la canzone. Infatti, nessun autore di prestigio invierebbe le sue canzoni ad un festival perché le possibilità di successo sono maggiori se i brani sono presentati in audizione, e poi perché i contratti editoriali lo impediscono. L'audizione ammazza il festival e riesce pure a sopravvivere per quasi mezzo secolo perché, nonostante la semplice carrellata di canzoni, riesce ad evolversi ed a mutare secondo il periodo e i cambiamenti dei gusti del pubblico. Addirittura, dalla prima metà degli anni '40 del Novecento, viene inquadrata e proposta sotto forma di rivista con il corpo di ballo, i comici, i presentatori e gli attori che recitano la satira. Nonostante il cambiamento, nelle altre città d'Italia nei primi anni dell'abbandono della formula festivaliera, si continua a richiedere la gara canora e, per questo motivo, alcuni editori, dopo aver presentato l'audizione di Piedigrotta, su richiesta, la trasformano in gara canora, come accadde nel 1907 quando Francesco Feola, dopo aver presentato tutte le canzoni della nuova produzione della casa editrice La Canzonetta al Caffè Suisse di Portici nelle esecuzioni di Elvira Donnarumma, su richiesta di Giovanni Cruciani, proprietario del teatro Eden di Roma, organizza un nuovo cast che va a sfidarsi nel locale della capitale con le stesse canzoni già proposte al pubblico napoletano. Tra le ultime richieste, quella del 1910 del cav. Repetto, proprietario del Varietès di Genova, che chiede esplicitamente agli editori Raffaele Izzo e Ferdinando Bideri di poter organizzare una sfida canora e non una semplice carrellata di nuove canzoni di Piedigrotta. Anche in quest'occasione, sia Izzo che Bideri hanno già presentato la nuova produzione e, per accontentare Repetto, selezionano le canzoni più applaudite per il festival ligure. Un gradevole ritorno della caratteristica gara canora avviene nel 1920, quando l'editore Alfredo Curatoli stupisce l'ambiente dello spettacolo presentando al pubblico il Concorso fra le donne musiciste italiane. Per la prima volta nella storia della musica in Italia viene organizzato un festival tutto al femminile. Sono, infatti, tutte donne gli autori dei testi e delle musiche delle canzoni in gara e tutte donne i cantanti del cast. L'unico uomo presente nell'intera organizzazione festivaliera è l'editore Curatoli, a cui si deve la stupefacente iniziativa. Ovviamente il festival delle donne viene totalmente snobbato e anche ostacolato, tanto è vero che non avrà futuro e questa del 1920 è l'unica edizione disputata. Nel 1947, dopo anni di assenza, fa ritorno il Festival di Piedigrotta, questa volta organizzato dalla Rai (Radio Audizioni Italiane) di volta in volta in collaborazione con l'Associazione Napoletana della Stampa, dell'E.N.A.L. (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori), del Comitato Feste di Napoli, ecc. La formula utilizzata è quella prettamente festivaliera (come quella attuale) con la gara canora, le tre serate (di cui due eliminatorie), le qualificazioni e la classifica finale delle migliori tre canzoni.
Abecedario di Castellammare al Volturno. Genealogia, cognomi e toponomastica nella storia di Castelvolturno
Annamaria Barbato, Arturo Bascetta
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 268
Un microscopico borgo medioevale di braccianti e massari. La Castel Voltuno del 1700 non è una città. Anzi, a dire il vero, si presenta come un piccolo borgo. Così lo si deve descrivere sfogliando, pagina dopo pagina, il Catasto Onciario dell'allora Castello a Mare del Volturno. Di esso si trascrivono fedelmente le notizie essenziali con l'elenco delle famiglie numerate e riordinate per cognome del capofamiglia, anziché per nome, come nell'originale. Non siamo a grandi livelli urbanistici in quanto la nuova Via Nazionale non è stata ancora costruita e il commercio maggiore è dovuto solo al via vai verso i santuari. Ma sfogliando le pagine concentrate in quest'Appendice, si ha un'idea più concreta di cosa sia un paese del 1700, con la sua piazza, le prime strade ufficiali, la parrocchia e le altre chiese intorno a cui si riuniva la popolazione. Tutto registrato e trascritto dai deputati et estimatori che hanno redatto il Catasto consultato nella copia microfilmata a partire dal frontespizio, quando compare la scritta ufficiale: Catasto seu Onciario dell'Unità di Castello a Mare del Volturno in Prova di Terra di Lavoro. Vale a dire il libro del Catasto oppure detto Onciario relativo all'Università comune del paese di Castello, meglio definito nel luogo del Mare del Volturno, nella provincia di Terra di Lavoro. È così possibile conoscere i nomi di tutti i capifamiglia trascritti in ordine alfabetico di cognome, con relativo mestiere e composizione del nucleo familiare, seguito dal parametro dell'oncia per stabilire l'esatto valore del reddito imponibile. Seguono le rubriche delle Vedove, Vergini e Bizzoche, dei cittadini e delle cittadine assenti, dei sacerdoti reverendi, cioè dei cittadini secolari, Chiese e Luoghi pii. Seguono le ultime rubriche catastali con i Forestieri abitanti, e i Forestieri non abitanti, cioè Bonatenenti Esteri, con gli Ecclesiastici Bonatenenti Esteri e le relative chiese straniere che possedevano dipendenze e beni sul territorio. Dopo l'elenco a parte che estrapola i beni della Parrocchia, tassati diversamente in base al Concordato con la Chiesa, il tutto, viene registrato, confrontato e assommato nell'operazione di sommatoria definitiva delle tasse, che va sotto il nome di Collettiva delle once, per stabilire l'esatto importo della dichiarazione totale del reddito imponibile relativo all'Università comune di Castello. Sfogliando queste pagine, si ha la certezza che siamo lontani dai grandi industrianti, dai fabbricatore di panni ai cavapietre mariani, anche poveri, come quelli incontrati a San Benedetto di Caserta. Non compaiono neppure sbirri, come a Toro di Caserta, accosto ad un'altra figura, quella del satellite, una sorta di spia, addetto ai rapporti con la polizia. Quando anni dopo assisteremo alle ribellioni e all'invasione del Regno Borbonico, specie nel decennio seguito ai fatti del 1799, la figura del satellite sarà una delle protagoniste delle rivolte antiliberali che sfoceranno nel brigantaggio, allorquando i paesi riconquistati dagli squadroni borbonici, cioè dalla polizia militare, si dicevano presi dai satelliti che ebbero il loro rifugio segreto in Mugnano, dove si riuniranno con il deposto intendente di P.U., Mirabelli, per progettare i loro 'golpe'. È più facile reggere le redini e spadroneggiare in un piccolo casale con pochi ricchi di un certo spessore. Hanno tanto di servi propriamente detti, diremmo quelli da comando o servitori, intesi come camerieri, e anche servi di livrea, cioè in divisa, come Antonio Maturo, servente in livrea di Crotone. Spesso la divisa non era neppure di loro proprietà e veniva conservata, o anche indossata, direttamente dal signore, come nel caso di Don Francesco Grillo di Oppido Mamertino, il quale, fra i suoi beni, possedeva una lebrea di servitore ed altra di volante. Sarà pure piccola Castel Volturno, ma lavorano tutti. Del resto non vi sono neppure figli adottivi.
Trattorie, piatti e ricette antiche dell'Irpinia. Il Vesuvio a tavola sulla via delle Puglie. Volume Vol. 2
Arturo Bascetta, Annamaria Barbato
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 238
È un libro incredibile, che segue la prima edizione, divenuta icona in quanto finalista mondiale a rappresentare l'Italia delle ricette antiche dei Romani, alla mondiale del più famoso concorso mondiale. Sono storie, volti di albergatori, trattorie, nomi e cognomi, prodotti antichi della terra e ricette vere, trascritte, cucinate, assaggiate e fotografate. La possibilità di acquistare una farina migliore o un tipo di semola particolare casomai prodotto nel paese accanto e non nel proprio sono alla base della rinnovata tradizione che si sposta lungo le vie di comunicazione con Foggia, con Napoli, con Salerno. Nel circondario avellinese, più propriamente, erano Sabino Barbato, Modestino Barbato, Pasquale Di Nardo, Saverio Falcone, Giuseppe Galasso, Francesco Guarino e Sabato Urciuoli a far macinare e commerciare farina di grani teneri burrattata, pane e biscotti di prima e media qualità, pasta di farina, farina di grani teneri con crusca, pasta di semola, semola burrattata e farina di grano duro e secoma con crusca. La farina partiva poi per Napoli, Salerno, Benevento, per i paesi della provincia dove veniva utilizzata dalle prime botteghe della pasta, sparse qua e là per la strada principale di Avellino e da trattorie e bettole che cominciavano ad aprire i battenti anche nei paesi. Era facile riconoscerle in quanto vi si vedevano donne lavorare la pasta a mano con i ferretti fra le mani e le tavole tonde sulle ginocchia. Ricciolilli, Ricci alla foretana, Cannellini, Cannolicchioni, Coccetelle, Recchie di prete, Gnocchi, Laganelle e Lasagne erano le specialità delle piccole poteche di città. Ad Avellino erano conosciutissime ed apprezzate quelle di Sabino Barbato al Corso, di Consolato Capaldo nel Larghetto della Dogana, di Filomeno De Stefano in via Due Principati, di Pasquale Di Nardo a Porta Napoli, di Giuseppe Galasso a Piazza Della Libertà e di Sabato Urciuolo in Piazza Centrale. Verso la fine del 1880, più che di botteghe vere e proprie, assistiamo alla nascita diretta di trattorie, osterie e bettole. Una volta pronta, la pasta veniva asciugata davanti ai portoni, ma anche sui davanzali delle case cosicché, come oggi si spandono i panni - per dirla alla Valagara - ieri si spandevano le tagliatelle sulle canne appese alle finestre. La buonissima pasta fatta in casa prendeva soprattutto la strada della città e quella che restava era smerciata a Napoli e a Salerno nei giorni di festa. La maggior parte della pasta di cui abbiamo notizia si produceva ad Avellino in quanto era destinata a Piazza Della Libertà: alla cucina dell'Hotel Centrale di Galasso e al ristorante Della Sirena di Domenico Cristiano. Più di una erano le trattorie frequentate anche dai forestieri come Giardini d'Inverno di Domenico Nevola a via Clausura e quelle di Generoso Tino e Generoso Cucciniello in via Beneventana. La lista continua con Stanislao Festa in via Luigi Amabile, Antonio Carulli in via della Sapienza, Giuseppe Coppola a piazza Garibaldi, Nicola Cerulli al Corso. Per finire con la Trattoria del Genio in via Trinità e il ristorante Del Barone di Generoso Rosapane in via Costantinopoli. Su queste basi abbiamo la nascita di vere e proprie trattorie e la loro espansione lungo le vie principali della città e dei paesi ai piedi della montagna del Partenio dove svettano il monastero verginiano di Mamma Schiavona, quello camaldolese dell'Incoronata, quello di San Silvestro, quello di Madonna Stella. Sul versante pugliese, invece, qualche locanda nacque fra Nusco e Sant'Angelo dei Lombardi verso San Salvatore al Goleto e Sant'Amato; a Caposele, sulla via per la Madonna di Materdomini; eppoi a Montemarano per San Giovanni, a Montoro per l'Incoronata e così via. Il libro si arricchisce dei nomi di tutti i bettolieri e albergatori e baristi e trattori di tutti i paesi della provincia di Avellino, con le foto a colori di molte ricette antiche raccontate dai nonni e cucinate ancora oggi.
Fli tra realtà e magia
Flavio Franceschino
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2025
pagine: 86
Quando l'undicenne Fli trova la chiave nascosta sotto una mattonella del giardino, non immagina che quel piccolo oggetto lo condurrà nel cuore del segreto più grande lasciatogli dal padre Peter, misteriosamente scomparso. Tra un'agenda di incantesimi, una pipa capace di rendere invisibili e una profezia oscura, Fli scopre che il male ha un nome: Evil Black, la creatura che ha distrutto la sua famiglia e ora vuole lui. Per sfuggire al suo destino e ritrovare la verità, Fli intraprende un viaggio verso l'enigmatico paese di Cold River, dove lo attendono lo zio Joseph, una villa piena di magie dimenticate e un lago nero abitato da mostri leggendari. Con l'aiuto del fazzoletto incantato, dell'amica strega Aras e dei ricordi del padre, il ragazzo affronta prove sempre più pericolose, fino a scoprire il tesoro nascosto che tutti cercano. Ma la ricchezza più grande non è fatta d'oro né di pozioni immortali: è nella forza di scegliere il bene, di proteggere chi si ama e di trasformare il dolore in un nuovo inizio. Età di lettura: da 7 anni.