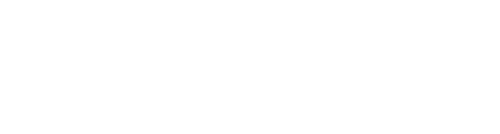Libri di Emilio Bove
Islam a Telesia, le incursioni arabe e saracene nel Sannio longobardo. Viaggio nel tempo sulle invasioni che portarono devastazioni, epurazioni e saccheggi fra Volturno e Calore, raggiungendo il cuore della Valle Telesina di Telese
Emilio Bove
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2024
pagine: 144
Una trasmissione radiofonica, parodia dei Tre Moschettieri di Dumas, fu sponsorizzata dalle due più importanti aziende italiane della catena alimentare: la Buitoni, nata nel 1827 a Sansepolcro in provincia di Arezzo e la Perugina, famoso marchio alimentare di rilievo nazionale, creato nel 1907 da Francesco Buitoni, Luisa Spagnoli e da suo marito Annibale. Tra tutte le figurine, quella maggiormente ricercata fu il "feroce Saladino", una vera e propria rarità. Per volere delle ditte, quella figurina venne distribuita così poco da farla diventare merce di scambio in una sorta di mercato nero. ll movimento creatosi intorno a questo personaggio, lo fece diventare celebre. L'immagine del saraceno raggiunse quotazioni notevoli e contribuì in maniera determinante al successo dell'iniziativa pubblicitaria scatenando una morbosa curiosità intorno a questa figura. Chi era il feroce Saladino? L'immagine proposta nel disegno delle figurine era frutto della fertile matita di un disegnatore torinese Angelo Bioletto e rappresentava l'icona stessa della ferocia musulmana. Un vero e proprio terrorista ante litteram. L'espressione arcigna, il naso prominente, la fronte corrugata sotto l'elmo con la mezzaluna rappresentavano i tratti salienti del guerriero che veniva raffigurato mentre imbracciava uno scudo ed una scimitarra. Ancor oggi la sua figura si presta a parecchie similitudini con i più moderni combattenti palestinesi o ai guerriglieri dell'Isis. Il mito del feroce Saladino, figura favolosa dall'alone quasi mitologico, altro non è che il prodotto di una cultura di derivazione medievale che riteneva gli Arabi esseri inferiori, rozzi e primitivi, infedeli in quanto non aderenti alla chiesa cristiana e pertanto indegni di appartenere alla civiltà latina. Nei libri di storia, Saladino viene riconosciuto come il sultano d'Egitto e di Siria, fondatore della dinastia degli Ayyubiti. Di ortodossia sunnita, combatté incessantemente i crociati estendendo il suo dominio dall'Egitto alla Palestina, dalla Siria allo Yemen. Le sue gesta impavide ispirarono poeti e scrittori e diedero vita ad una fiorente letteratura, oltre che a film e a spettacoli musicali. La sua figura di condottiero audace e spietato fu raccontata da numerosi cantori, che posero in risalto l'abilità guerriera e la crudeltà ma anche le virtù cavalleresche, la prudenza e la razionalità nell'assumere decisioni politiche. Lo stesso Dante lo citò nel Convivio e nella Divina Commedia ponendolo nel limbo, tra gli spiriti "magni". Da questa premessa è partita la penna del dottore Emilio Bove per ricordarci delle invasioni musulmane nel Mezzogiorno. Con un excursus dai Longobardi all'Età moderna, allorquando le fazioni in lotta chiamarono a combattere sotto le loro insegne truppe mercenarie islamiche che trasformarono il Sannio in terra di incursioni e di saccheggi e si trasformarono da semplici mercenari in veri e propri conquistatori. Vasti territori del Sannio furono investiti dalle loro scorribande. Gli aggressori proruppero dovunque senza eccessivi problemi: giunsero al mare, risalirono lungo il corso dei fiumi, avanzarono a cavallo attraversando terre incolte e abbandonate. I loro condottieri divennero tristemente famosi: l'esercito di Halfūn al-Barbarī volse le proprie scimitarre in Puglia creando a Bari il primo emirato arabo; le bande saracene di Sāwdan al-Māzari assaltarono a più riprese la città di Telesia, devastando la cinta muraria e interrompendo le condutture dell'acquedotto, per costringere la città a capitolare. Ovunque la feroce jihād islamica contro gli infedeli fu causa di desolazione e morte.
FU la peste: maghi, ciarlatani, taumaturghi, guaritori. Epidemie in Italia e nel Sannio dal Medioevo in poi
Emilio Bove
Libro: Libro rilegato
editore: ABE
anno edizione: 2024
pagine: 184
Sono trascorsi oltre due secoli dalla definitiva scomparsa della peste, eppure questa malattia rappresenta ancora oggi il simbolo assoluto del morbo mortale. Il più spaventoso, il più drammatico, il più terrificante di tutti. Nell'evo antico la peste era sinonimo di flagello mortale, di una grave calamità, di una catastrofe inesorabile, portatrice di morte e di sventure. Era la punizione che gli dei imponevano agli uomini responsabili di aver trasgredito ai loro voleri. Anche nel Sannio questa piaga era temuta come il peggiore dei mali che potesse capitare in una comunità. E di questo il nostro territorio conserva ancora intatte e le sue tracce. «Fu la peste 1656» è un'iscrizione che si trova incisa alla base di un portale in pietra all'ingresso della chiesa parrocchiale di Pietraroja: un paesino montano della provincia di Benevento, poco più di 500 anime residenti sulle pendici del massiccio del Matese nell'Appennino meridionale. Questa epigrafe è un vero e proprio frammento di storia e conserva il ricordo di un periodo vissuto dalla popolazione sannita e di un evento, minaccioso e forte, che sconvolse l'intera società sannita. Saxa loquuntur, dicevano i latini: le pietre parlano. Nei secoli passati, infatti, gli eventi più importanti venivano spesso affidati alle lapidi, impressi nella pietra per sottrarli all'oblio e per consegnare il messaggio alla memoria storica. Era questo, d'altronde, uno dei pochi strumenti di informazione che i popoli avevano con il futuro. Forse tra i più efficaci. Ma, da cosa scaturisce la necessità di comunicare un evento così drammatico, come quello della peste, con una modalità così importante, come quella di scolpirlo nella pietra? Indubbiamente tra tutti i flagelli, quello della peste era vissuto dalla società di allora con un misto di angoscia, terrore e rabbia. La paura non riguardava solo la possibilità di una morte atroce, evento molto frequente, ma anche le sue conseguenze sociali e finanziarie. Il tormento più grande era quello di non potersi difendere; non c'erano rimedi in grado di combattere il terribile morbo; rimaneva solo l'angoscia costante di perdere la vita, i propri averi, gli affetti più cari. Contrarre la peste significava sostanzialmente morire. E morire da disperati, senza alcun conforto, senza la vicinanza dei familiari e il più delle volte senza la possibilità di una degna sepoltura. Per fortuna, col tempo, molte cose sono cambiate. Proprio nel campo dell'infettivologia, la scienza medica ha fatto progressi da gigante e molte malattie non fanno più paura come una volta. Tuttavia, la peste esiste ancora. Così come esistono la tubercolosi, il colera, la lebbra, l'Aids e tante altre malattie infettive. Il pericolo, inoltre, è sempre in agguato, come dimostra la recente pandemia da Sars-CoV2 (Severe acute respiratory syndrome-Coronavirus2), meglio conosciuta come Covid-19. La storia dell'uomo, infatti, è storia delle malattie. E tra tutte, la peste si è sempre dimostrata la più terribile emergenza sanitaria: una calamità che si abbatteva ciclicamente sulla popolazione. Nel corso dei secoli si sono succedute innumerevoli pestilenze, molte delle quali in grado di provocare un collasso sociale, come la "morte nera" nell'Europa del XIV secolo, responsabile del decesso di quasi un terzo della popolazione dell'intero continente e che fu alla base di importanti cambiamenti sociali e culturali. Nell'Italia meridionale e nel Sannio l'epidemia più devastante fu quella del 1656, responsabile di una vera e propria catastrofe demografica. Il terribile morbo soggiornò a lungo nel Mezzogiorno, anche perché la scienza medica si dimostrò completamente disarmata nei confronti della malattia. Con l'avvento degli antibiotici ed il miglioramento delle condizioni di vita, oggi la peste non rappresenta più lo spauracchio di una volta. Ma quali sono le attuali conoscenze scientifiche su questa malattia?
Il vescovo e il liberale. Legittimismo e liberalesimo in due protagonisti della nuova Italia
Nicola Vigliotti, Emilio Bove
Libro
editore: Vereja
anno edizione: 2011
pagine: 174
Catasto Onciario della Terra di San Salvatore in Terra di Lavoro
Emilio Bove, Antonio Bove
Libro
editore: FioridiZucca Edizioni
anno edizione: 2024
pagine: 336
Diario delle giornate di deportazione
Libro: Libro rilegato
editore: FioridiZucca Edizioni
anno edizione: 2022
pagine: 80
Un diario anonimo sul rastrellamento e la deportazione della popolazione civile di San Salvatore Telesino in provincia di Benevento nell'ottobre del 1943. Con note introduttive e approfondimento storico a cura di Emilio Bove.