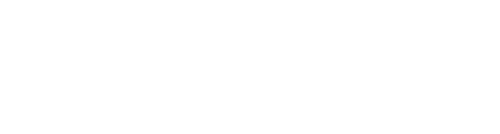Libri di Marianna Liguori
La cultura del romanzo. Giovan Francesco Loredan nella società letteraria del Seicento
Marianna Liguori
Libro: Libro in brossura
editore: Bites
anno edizione: 2025
pagine: 224
Il patrizio veneziano Giovan Francesco Loredan (1607-1661), fondatore e principale animatore dell'Accademia degli Incogniti, è figura di rilievo nel panorama letterario del Seicento, noto per le sue abilità di mediatore culturale e per la sua attività di mecenatismo, di cui beneficiarono soprattutto i romanzieri emergenti. Descritto negli studi come un vero e proprio "dittatore letterario" del suo tempo, per il controllo capillare esercitato sull'industria libraria, Loredan fu anche autore di una vastissima produzione in prosa, considerata finora solo in maniera sporadica, ma ben rappresentativa della cultura letteraria di un'intera generazione di scrittori Incogniti. Ricostruendo le tappe della formazione di Loredan e considerando le sue scritture degli anni Trenta – a partire dall'opera d'esordio, gli Scherzi geniali (1632 e 1634) –, il percorso proposto in questo volume giunge a mostrare l'eccezionale stratificazione di saperi, modelli e materiali che nutrono il romanzo più importante di Loredan, la Dianea (1635), con il duplice obiettivo di proporre una più adeguata collocazione della sua opera nelle diverse correnti della letteratura del Seicento, e, invertendo la prospettiva, di offrire un esempio significativo della variegata cultura che informa i romanzi del tempo.
Lettere. Antologia della corrispondenza
Vittoria Colonna
Libro: Libro in brossura
editore: Marsilio
anno edizione: 2025
pagine: 880
La voce di Vittoria Colonna fu una delle più autorevoli del Cinquecento. Protagonista di eventi che hanno movimentato la storia politica e religiosa del secolo, vanta primati eccezionali in letteratura, essendo stata la prima poetessa italiana a godere di una stampa e di un commento alle proprie rime mentre era ancora in vita. L’edizione commentata di una corposa parte delle sue lettere e di quelle dei suoi corrispondenti, fra i quali si contano papi, sovrani italiani ed europei, alti prelati, letterati come Aretino, Bembo, Castiglione, Tasso o artisti del calibro di Michelangelo, restituisce il ritratto di una donna di potere che seppe mostrare volti diversi e guadagnarsi un ruolo importante nella cultura di primo Cinquecento. L’elegante celebrazione del nome di Vittoria è una costante di queste lettere, che lasciano traccia di un’idea di letteratura intesa anche come “gioco di società”, fatta di strategie comuni e replicabili all’infinito (come i diffusissimi giochi di parole sul nome «Vittoria»); ma la storia del carteggio di Colonna è anche quella di disastri familiari, di necessarie bugie, di battaglie diplomatiche e religiose condotte senza risparmiare le energie, di una penna capace di lucide analisi politiche o abile a trasformarsi per assecondare il gusto dei corrispondenti.
Oltre i «termini» della lettera. Pratiche di dissertazione nelle corrispondenze tra Quattro e Cinquecento
Libro: Libro in brossura
editore: Edizioni di Archilet
anno edizione: 2022
pagine: 198
Nel Cinquecento la radicale consapevolezza della complessità e della varietà intrinseche della scrittura epistolare conferma la lettera come strumento duttile, adatto anche all’elaborazione del pensiero teorico. Lo studio dei testi e delle prassi editoriali, tuttavia, induce a problematizzare il concetto di “duttilità” della lettera di Antico Regime e a domandarsi quanto pesi sulla sua definizione il filtro dell’osservatore odierno. Da qui, la necessità di indagare il rapporto formale e contenutistico tra il genere-lettera e la prosa “trattatistica”, analizzandolo su diverse direttrici di ricerca: le questioni di retorica (in particolare legate alle variazioni del codice delle lettere discorsive rispetto al “grado zero” della comunicazione familiare e privata); il modo in cui singoli autori affrontano uno stesso tema passando dalla prosa epistolare a opere di altro genere; i problemi editoriali derivanti dalla scelta dello strumento epistolare in contesto precettistico; le prassi esegetiche adatte a tale tipologia testuale, e le nuove prospettive per riproporle oggi. I casi di studio qui raccolti, distribuiti su un arco cronologico che dall’epistolografia umanistica quattrocentesca giunge fino al pieno Cinquecento, rispondono tanto all’esigenza di tentare uno studio che non trascuri l’eredità dei grandi carteggi umanistici (qui indagati da Cristiano Amendola e da Chiara Azzolini); quanto a quella di analizzare il dialogo tra il genere-lettera e le tipologie di fonti e modelli direttamente sui testi (come nei contributi di Daniele Manfredi per Cavalcanti, di Roberta De Noto per Aretino, di Giorgia Gallucci per Caro, di Michela Fantacci per Giovio, di Isabelle Gigli Cervi per Beccadelli, di Nicolò Magnani per Ruscelli, e infine di Francesco Amendola per Bembo e Fracastoro). La varietà di argomenti e di generi “di contatto” offerta dai saggi consente così non solo di sondare le diverse declinazioni di tale dialogo, ma anche di presentare alcune prime prove pratiche di analisi ecdotiche in continua tensione tra alta specificità dei materiali e teoresi.
Regni di carta. Modelli politici e rappresentazione del potere nel romanzo ligure e veneto del Seicento
Libro
editore: Edizioni di Storia e Letteratura
anno edizione: 2026
pagine: 256
L'ingente produzione di romanzi italiani nel Seicento è da tempo oggetto di numerose indagini. Mancano tuttavia letture ravvicinate di singoli testi, come prova la scarsissima quantità di edizioni moderne disponibili. Il volume intende promuovere un focus ravvicinato sui romanzi di area genovese e veneziana, proponendo quindi un'analisi approfondita dei testi e mettendo in evidenza le digressioni politiche inserite in essi. Nella consapevolezza del ruolo cruciale del discorso politico-diplomatico nella narrativa del seicento i contributi intendono valutarne le specificità nelle opere sorte in contesto repubblicano.