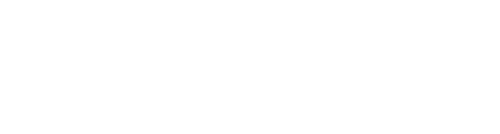Libri di Nadia Urbinati
Società e solitudine
Ralph Waldo Emerson
Libro: Libro in brossura
editore: Orthotes
anno edizione: 2025
pagine: 222
I saggi qui raccolti – Società e solitudine, Amicizia, Doni, La superanima, Vita e letteratura nel New England, Carattere – permettono di cogliere il delicato equilibrio che Emerson stabilisce tra istanze sociali e fiducia in se stessi. Lo spirito moderno sta dal lato dell’individuo, che riassume in sé il mondo. Tuttavia, volgendosi a guardare le grandi utopie di prosperità sociale della generazione precedente, Emerson mostra benevolenza verso quei progetti generosi, mettendo solo in guardia da eccessi comunitari. L’uomo di «carattere» mira all’autosufficienza, eppure su questo fondamento si apre la possibilità di una gioiosa interazione con le persone e di autentici rapporti amicali. Ciò che si dona è qui il proprio stesso essere, l’unico dono che non umilia il beneficato.
Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri
Nadia Urbinati
Libro: Copertina morbida
editore: Donzelli
anno edizione: 2010
pagine: 247
È vero che la democrazia rappresentativa è un ossimoro? Che democrazia significa governo diretto? Nadia Urbinati sostiene di no: la democrazia rappresentativa non è un ripiego rispetto al modello ideale di democrazia diretta, bensì una forma originale di governo democratico che è peculiare della società moderna e nella quale forme di partecipazione diretta e forme di politica rappresentata si integrano in maniera articolata e ricca. La rappresentanza è, dunque, una forma complessa di partecipazione, un processo politico che genera e si sostiene su un continuo flusso di influenza, controllo e comunicazione tra cittadini e rappresentanti. In un percorso che risale alla genesi della democrazia dei moderni, il libro passa in rassegna le discussioni che nella Francia rivoluzionaria coinvolsero critici, scettici e sostenitori del governo rappresentativo, da Rousseau a Sieyès e Kant, da Paine a Condorcet. L'obiettivo è dimostrare come, proprio perché il nostro è un ordine politico che si regge su una sovranità democratica indiretta, si rendono necessarie nuove o rinnovate strategie di contenimento dei rischi di dispotismo indiretto degli eletti, ma anche nuove regole che garantiscano le condizioni di pluralismo dell'informazione per rendere possibile una libera ed efficace articolazione del giudizio politico e consentire all'opinione pubblica di svolgere un ruolo non solo di consenso ma anche di critica e sorveglianza del potere costituito.
Missione impossibile. La riconquista cattolica della sfera pubblica
Marco Marzano, Nadia Urbinati
Libro: Copertina morbida
editore: Il Mulino
anno edizione: 2013
pagine: 138
Circola da tempo un pensiero post-secolare che invoca il ritorno della religione nella sfera pubblica, con l'auspicio che faccia da collante etico-politico per democrazie ormai sfibrate. Ma in una società di fatto monoreligiosa come quella italiana l'attivismo politico del cattolicesimo comporta un rischio serio per l'autonomia della legge civile, come ha mostrato la vicenda del crocefisso nelle scuole pubbliche. D'altra parte l'operazione si presenta rischiosa anche per la Chiesa stessa. Il "progetto culturale" con cui il Cardinal Ruini, presidente della Cei per oltre quindici anni, si proponeva di rilanciare il ruolo pubblico dei cattolici era rivolto a un mondo che non esiste più dagli anni Cinquanta. Da allora sono profondamente cambiati gli interessi e le preoccupazioni dei fedeli, le forme del credere e gli stili di aggregazione. La centralità della coscienza individuale e un reale pluralismo interno hanno preso il posto di gerarchie e liturgie tradizionali. Tentare di tradurre in politica la forza di queste esperienze religiose è dannoso e velleitario per chi ha a cuore il futuro della fede.
La mutazione antiegualitaria. Intervista sullo stato della democrazia
Nadia Urbinati
Libro: Libro in brossura
editore: Laterza
anno edizione: 2013
pagine: VIII-161
La nostra democrazia sta subendo un processo di mutazione molecolare di cui non riusciamo ancora a ogliere la direzione. Nel suo aspetto più visibile la mutazione è politica ed economica. Riguarda la composizione sociale della cittadinanza, il rapporto tra le classi e il governo dell'economia pubblica e si manifesta come una mutazione in senso antiegualitario. Nel suo aspetto meno visibile la mutazione è culturale e ideale e si presenta come appropriazione identitaria della libertà e dell'eguaglianza dei diritti civili. Se volgiamo poi lo sguardo alla sfera della vita privata, ai cambiamenti intellettuali, sociali e politici, scopriamo che esiste una maggiore distanza tra le persone in relazione alle opportunità che hanno di acquisire beni effettivi e simbolici. Siamo forse alla vigilia di un cambiamento paradigmi sociali e politici?
Liberi e uguali. Contro l'ideologia individualista
Nadia Urbinati
Libro: Copertina morbida
editore: Laterza
anno edizione: 2012
pagine: 171
La modernità come cultura dell'individualità (e perciò dei diritti) e la modernità come individualismo economico e tecnica del potere: questa dicotomia ha fatto da cornice alla nascita della democrazia a partire dal Sei-Settecento. Ha anche reso complessa la critica all'individualismo, il cui opposto non è solamente una società cetuale e antimoderna. L'individualismo democratico è l'alternativa più coerente all'ideologia individualista perché è una cultura politica e morale di rispetto della persona, dei suoi diritti e della sua fondamentale eguaglianza. Il suo opposto non è soltanto un mondo strutturato per gerarchie, ma anche un modo di concepire la società moderna come dominio del privato. L'individualismo non denota la fine della politica, ma invece un modo di concepire la sfera pubblica come la sede dove si creano diritti, regole e istituzioni per riuscire a condividere i beni comuni e apprendere a rispettarsi quando interessi e idee divergono, senza cercare né la fuga dalla politica né la sua subordinazione ai voleri e alle passioni del privato.
Prima e dopo. La brutta china della democrazia italiana
Nadia Urbinati
Libro: Copertina morbida
editore: Donzelli
anno edizione: 2011
pagine: 232
Una democrazia sotto stress è come un laboratorio che ci fa vedere ingranditi i possibili vizi del governo democratico. E non c'è dubbio che l'Italia del ventennio berlusconiano rappresenti esattamente lo stress, la tensione estrema, il rischio di implosione in cui una democrazia può cadere, se smarrisce il suo vero tratto distintivo, che è quello di saper garantire e tollerare le diversità attraverso un rispetto imparziale delle regole del gioco. Ma il caso limite della democrazia italiana ci consente - per paradosso - di metterne in luce anche la particolare virtù che, in un regime democratico, è rappresentata dal dissenso. Questo volume, che raccoglie le marcate prese di posizione espresse negli ultimi due anni sulle pagine del quotidiano "la Repubblica" da Nadia Urbinati, ci consegna un'analisi impietosa e realistica della società italiana a partire da una concezione procedurale della democrazia che è rigorosamente ancorata all'eguaglianza dei diritti e alla libertà civile e politica dei cittadini. Gli abusi e le manipolazioni della competizione politica e delle norme costituzionali ai quali abbiamo assistito in tutti questi anni diventano altrettante occasioni per dare valore sostanziale alle regole del gioco, per affermare le procedure democratiche come un bene comune e pubblico a tutti gli effetti, e per mostrare quanti danni possono derivare dal loro mancato rispetto.
Liberi e uguali. Contro l'ideologia individualista
Nadia Urbinati
Libro: Libro in brossura
editore: Laterza
anno edizione: 2011
pagine: 175
La modernità come cultura dell'individualità (e perciò dei diritti) e la modernità come individualismo economico e tecnica del potere: questa dicotomia ha fatto da cornice alla nascita della democrazia a partire dal Sei-Settecento. Ha anche reso complessa la critica all'individualismo, il cui opposto non è solamente una società cetuale e antimoderna. L'individualismo democratico è l'alternativa più coerente all'ideologia individualista perché è una cultura politica e morale di rispetto della persona, dei suoi diritti e della sua fondamentale eguaglianza. Il suo opposto non è soltanto un mondo strutturato per gerarchie, ma anche un modo di concepire la società moderna come dominio del privato. L'individualismo non denota la fine della politica, ma invece un modo di concepire la sfera pubblica come la sede dove si creano diritti, regole e istituzioni per riuscire a condividere i beni comuni e apprendere a rispettarsi quando interessi e idee divergono, senza cercare né la fuga dalla politica né la sua subordinazione ai voleri e alle passioni del privato.
Cosmopolitismo e nazione. Scritti sulla democrazia, l'autodeterminazione dei popoli e le relazioni internazionali
Giuseppe Mazzini
Libro: Libro in brossura
editore: Elliot
anno edizione: 2011
pagine: 344
Giuseppe Mazzini è oggi ricordato soprattutto come il principale e instancabile ispiratore morale e politico del Risorgimento italiano. Eppure, il suo ascendente intellettuale travalica i confini della madrepatria e del suo secolo. Nell'epoca in cui visse, fu tra i maggiori intellettuali europei, al pari di Michail Bakunin e Karl Marx, John Stuart Mill e Alexis de Tocqueville. La sua visione politica era fondata su saldi princìpi politici e ideali di progresso, dal suffragio universale di donne e uomini alla giustizia sociale. Ma tra i temi che gli stavano più a cuore quello più importante era la riscrittura dell'assetto politico europeo sulla base di due princìpi fondamentali: la democrazia e l'autodeterminazione nazionale. L'intento principale di Mazzini era quello di influenzare il pensiero e l'opinione dei popoli, nella convinzione che un mutamento politico così profondo richiedesse innanzitutto un mutamento dell'opinione politica e culturale diffusa. Seguendo l'esempio di Jean-Jacques Rousseau, Mazzini considerava gli esseri umani per quello che effettivamente erano, e le leggi per come avrebbero dovuto essere: i primi liberi ed eguali, con i propri valori e le proprie passioni, in grado di imparare a vivere e ad associarsi agli altri in maniera pacifica; le seconde quali premesse essenziali per convogliare le energie e le aspirazioni del popolo verso un'autentica emancipazione politica e morale.
Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle democrazie moderne
Nadia Urbinati
Libro: Copertina morbida
editore: Donzelli
anno edizione: 2009
pagine: 131
Il governo rappresentativo è davvero democratico? O invece non lo è perché non consente ai cittadini di votare direttamente le leggi che dovranno rispettare? Le opinioni dei teorici della politica su questo tema si dividono. C'è chi lo considera una forma di governo misto, per metà aristocratico o oligarchico e per metà democratico. Chi, svuotandolo di ogni valore normativo, lo accetta soltanto come un espediente necessario. Per gli uni la democrazia è semplicemente elettorale e la rappresentanza ne è l'esito istituzionale. Per gli altri la democrazia è partecipazione diretta e la rappresentanza ne è una violazione. Riflettendo su un tema tanto spinoso, Nadia Urbinati accoglie la sfida di mettere in discussione una tale polarizzazione. La democrazia rappresentativa è una forma unica di governo democratico peculiare delle società moderne: non costituisce un'alternativa alla partecipazione, né tuttavia limita la democrazia al momento elettorale o alla conta dei voti. La rappresentanza è, dunque, una forma complessa di partecipazione, un processo politico che genera e si sostiene su un continuo flusso di influenza, controllo e comunicazione tra cittadini e rappresentanti.
Il bene e il giusto
Nadia Urbinati
Libro: Libro in brossura
editore: Forum Edizioni
anno edizione: 2013
pagine: 64
Quale rapporto esiste tra i concetti di 'bene' e 'giusto'? Quali sono i principi di una giustizia equa, che tutte le componenti della società possono razionalmente accettare e condividere? 'Bene' deriva da bonus, buono, 'giusto' da iustum, conforme al diritto. Nella nostra vita democratica la tensione fra questi due principi è centrale e attraversa problematiche complesse: la crisi della rappresentanza politica, il confronto (necessariamente conflittuale) fra interessi individuali e finalità collettive, il ruolo della norma nella realizzazione dell'uguaglianza, il diritto alla diversità, alla resistenza e alla disobbedienza civile; e infine la possibilità che il nostro sistema democratico sia in grado di riformare sè stesso.
Individualismo democratico. Emerson, Dewey e la cultura politica americana
Nadia Urbinati
Libro: Libro in brossura
editore: Donzelli
anno edizione: 2009
pagine: XL-199
Al principio del nuovo millennio si assiste a un energico ritorno dell'individualismo democratico, una delle più audaci espressioni della cultura politica moderna. Cresciuta nell'America dell'Ottocento grazie a personalità come Emerson, Whitman e Thoreau, quando la democrazia non era ancora una realtà acquisita, questa idea si impose ben presto come alternativa al razionalismo e all'utilitarismo e diede i suoi frutti con il pragmatismo di Dewey. Per la sua forte tensione etica si distinse dalla tradizione liberale, dalla quale ebbe origine. Per la sua attenzione al valore della dimensione privata della vita individuale si distaccò dalla tradizione repubblicana, della quale la nuova nazione americana era imbevuta. La sua idea fondamentale è che lo Stato costituzionale sia il punto di partenza grazie al quale il sistema politico e la società civile possono svolgere un'opera positiva di stimolo dell'individualità. In questo senso, la democrazia supera l'atteggiamento negativo verso la politica proprio del liberalismo, giacché propone a ciascuno di prendere parte, a suo modo e con responsabilità, alla costruzione di una prospettiva di miglioramento per se e gli altri, attraverso le leggi, la cultura, la partecipazione politica e il giudizio pubblico. La fragilità della democrazia, che e anche il suo fascino e la sua forza recondita, sta in questa dimensione più che politica, nell'avere non altro fondamento se non la credenza e la pratica di vita di ciascuno.
Ai confini della democrazia. Opportunità e rischi dell'universalismo democratico
Nadia Urbinati
Libro: Copertina morbida
editore: Donzelli
anno edizione: 2007
pagine: 137
Democrazia è insieme il nome di una forma di governo e di un ideale politico e morale. Questa doppia natura dà alla parola un significato complesso, con la conseguenza che alla democrazia chiediamo a volte troppo e a volte troppo poco. Le chiediamo troppo quando confondiamo il suo ethos universalistico con un progetto politico di espansione. Le chiediamo troppo poco quando la identifichiamo con l'appartenenza etnica, mortificandone il significato inclusivo ed egualitario. Nel primo caso, estendiamo la democrazia oltre i confini territoriali dello Stato per farne un progetto di governo globale o di democratizzazione forzata. Nel secondo caso, rischiamo di trasformarla in un governo di privilegiati che accetta di avere al suo interno residenti, che tuttavia non hanno gli stessi diritti dei cittadini. La democrazia ha una difficile relazione con i confini, ideologici o territoriali, e tale difficoltà è all'origine della sua schizofrenia. Le contraddizioni della nozione di democrazia sono alla base di questo saggio di una delle maggiori teoriche della politica contemporanee, che si interroga sui dilemmi di uno Stato democratico nell'era della globalizzazione. L'universalismo dei valori democratici autorizza a legittimare una democrazia cosmopolita? L'esigenza di autonomia politica che la democrazia contiene autorizza i paesi democratici a farsi missionari di democrazia? L'universalismo democratico può accettare di non prevedere politiche di inclusione rivolte agli immigrati?