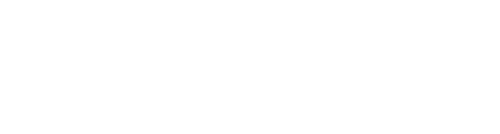Medusa Edizioni: Le porpore
Scrittori «contro». La rivolta nella letteratura francese tra secondo Ottocento e Novecento
Giuliano Vigini
Libro: Libro in brossura
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2021
pagine: 152
Il tema esaminato in questo saggio è uno dei più interessanti della letteratura contemporanea. Dopo un'introduzione generale che esamina i fattori di cambiamento che hanno determinato un nuovo scenario economico e politico-sociale in Francia e in Europa, il saggio esamina alcuni aspetti significativi (il male di vivere, la tragicità della condizione umana, la noia, la stupidità, le ingiustizie, l'avidità di denaro, i tradimenti ecc.) che motivano i perché della "rivolta" messa in atto da alcuni romanzieri, poeti e intellettuali francesi tra Ottocento e Novecento: da L'autré amont a Baudelaire, da Flaubert a Hugo, da Bloy a Péguy e Bernanos... A questi scrittori "contro" se ne affiancano altri che cercano di attuare la "rivoluzione del reale", ossia gli aderenti al movimento naturalista (i Goncourt, Zola, Huysmans...), che si oppongono alla "falsa letteratura" che li ha preceduti, convinti che l'arte nuova che incarnano debba essere fondata esclusivamente sui "documenti umani". Non meno ricchi di suggestioni sono i capitoli dedicati alla "rivolta cattolica", testimoniata dai suoi scrittori più rappresentativi (come Veuillot, Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam), e alla "ragione in rivolta" (Anatole France, Gide, Camus, Sartre), con cui si completa questo quadro della storia letteraria francese fra secondo Ottocento e Novecento, colta in alcuni suoi tratti caratteristici, ma anche nelle sottili differenze che distinguono e talvolta contrappongono per finalità e pensiero gli stessi scrittori qui presi in considerazione.
La chiave dell'Apocalisse. Le origini iberiche del popolo giudaico
Oscar Vladislas Milosz
Libro: Libro in brossura
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2021
pagine: 126
«"Milosz, in transe mi annuncia che Dio gli ha permesso di divulgare le rivelazioni trovate nell'Apocalisse. Poi cade in ginocchio e ringrazia per la grazia ricevuta. Tutto questo gli porta terribili tormenti di giorno e di notte che gli danno l'impressione di essere assediato dalla follia. Le sue argomentazioni, però, scorrono lucide e ragionevoli. Nell'Apocalisse tutto è previsto: è l'America, l'impero del diavolo e di Satana, che ha rinchiuso il mondo in una rete di sortilegi diabolici. 666 è la sua cifra, lo confermano l'ebraico e il basco, lingue che svelano il nome nascosto dietro quel numero: America". Così scrive Petras Klimas il 13 maggio 1933. Le parole riportate dal diplomatico lituano descrivono il furor che, negli ultimi anni di vita, si impadronisce di colui che, fino alle soglie del Primo conflitto mondiale, era per molti solo un poeta e uno scrittore. E così rimarrà nella mente di amici e ammiratori anche quando Oscar Vladislas de Lubicz Milosz si spegnerà a seguito di un'embolia, il 2 marzo del 1939, dopo aver tentato, invano, di riportare il suo canarino nella gabbia da cui era appena fuggito. Sulla lapide, al cimitero di Fontainebleau, sarà inciso "Poeta e metafisico". Per una ristretta cerchia di studiosi, era scomparso un grande scrittore a cui non era stato tributato il meritato riconoscimento forse anche a seguito di una presunta scomunica decretata dall'influente André Gide. Ma O.W. Milosz, come si firmava prima del 1914, oppure O.V. de L. Milosz, come preferiva chiamarsi negli ultimi anni di vita, non è stato solo un poeta. La sua quête non si esaurisce nella produzione di versi o nella ricerca spirituale condotta sulla scia della Cabala, di Swedenborg, di Meister Eckhart ma prosegue in una produzione intellettuale difficile da classificare e che grazie a questa traduzione di "Le origini iberiche del popolo giudaico", L'Apocalisse di San Giovanni decifrata e La chiave dell'Apocalisse in Italia si comincia solo oggi a scoprire.» (Simone Paliaga)
L'eloquenza delle lacrime
Jean-Loup Charvet
Libro: Libro in brossura
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2021
pagine: 132
«Le lacrime sono gravi eppur lievi - scrive nella Prefazione, il cardinale Ravasi -, intrecciano tragedia e grazia; anzi, presiedono al dolore e alla gioia perché se «il gemito è l'urlo del silenzio», è altrettanto vero che est quaedam flere voluptas, che c'è piacere nel piangere, come osservava Ovidio nei suoi Tristia (IV, 3, 27). Anzi, come diceva sant'Agostino, «nessuna cosa è talmente unita alla felicità quanto il pianto». Le lacrime, insomma, sono la «calligrafia dell'anima e dell'emozione». Lo sono anche per la stessa esperienza di fede. Il Salmista in un verso di straordinaria efficacia afferma che il Pastore supremo delle nostre anime, Dio, raccoglie nell'otre - che è quasi lo scrigno del nomade - le perle delle lacrime umane, registrandole una per una: «Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli: non sono forse scritte nel tuo libro?» (Salmo 56, 9). Per questo il maestro chassidico rabbi Mendel di Kotzk era convinto che «Dio preferisce le lacrime più delle preghiere», mentre il Bellarmino le considerava «il condimento della preghiera». Perché, come si scrive nelle pagine che si aprono davanti a noi, «la lacrima spegne il fuoco del peccato e attizza quello della grazia, è una cera che purifica l'anima incendiando il cielo». Purificato il cuore con il pentimento, «l'occhio vede bene Dio solo attraverso le lacrime» (V. Hugo). Queste e altre (molte altre) sensazioni, emozioni, riflessioni, intuizioni Charvet fa balenare nelle sue poche, dense eppur lievi pagine. La sua attenzione si fissa in particolare sull'amata "sensibilità barocca che ama dipingere i tratti di un viso che oscilla tra riso e pianto, gravità e leggerezza, esteriorità e interiorità". Soprattutto la musica lo aiuta a esprimere maggiormente la muta eloquenza del pianto. Il sontuoso apparato di citazioni - necessarie in un testo di questo genere - raggiunge il suo apice nell'armonia del linguaggio musicale, forse ancor più nitido di quello, pur decisivo, della visione pittorica».
Il ritorno di Raffaello. Romae Carrus Navalis
Giulio Aristide Sartorio
Libro: Libro in brossura
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2020
pagine: 354
L'unico romanzo scritto dal pittore Giulio Aristide Sartorio torna in libreria dopo oltre un secolo. Narra la prodigiosa resurrezione di Raffaello Sanzio: il suo monumento a Urbino, colpito da un fulmine, prende vita. Raffaello rinato si dirige a Roma, dove un pittore, spacciandolo per suo fratello, lo introduce nella società della capitale, nel periodo della guerra coloniale in Africa. Il genio redivivo, però, getta lo scompiglio nel bel mondo romano, ipocrita e corrotto: ed entrano in scena artisti ambiziosi, critici inetti, antiquari spregiudicati, modelle preraffaellite, femmes fatales, politici influenti, nobili decaduti... Nel 1904, nella casa-convento di Francesco Paolo Michetti a Francavilla, la stessa dove D'Annunzio aveva composto Il Piacere, il pittore Giulio Aristide Sartorio, gran protagonista dell'arte preraffaellita e simbolista, completa il suo unico romanzo "Romae Carrus Navalis". Pubblicato nel 1905 da Treves, dopo l'iniziale fortuna il libro cade nell'oblio. Medusa ora lo riscopre dopo oltre un secolo dalla sua edizione. Questa Favola contemporanea (così il sottotitolo) narra la prodigiosa resurrezione di Raffaello Sanzio: il suo monumento a Urbino, colpito da un fulmine, prende vita il giorno della sua inaugurazione (1897). Raffaello si dirige a Roma, dove il pittore Alessandro Brandi, spacciandolo per suo fratello, lo introduce nella società della capitale. Il genio redivivo, però, getta lo scompiglio nel bel mondo romano, ipocrita e corrotto. Attraverso lo sguardo ingenuo di Raffaello e quello disincantato di Brandi, alter ego dell'autore, Sartorio rivela l'enorme distanza che separa l'amato Rinascimento dalla realtà contemporanea, volgare e grottesca, simile a un eterno carnevale.
Ipotiposi. Vagabondare per immagini
Mario Porro
Libro: Libro in brossura
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2020
pagine: 214
Ci sono vocaboli che piacciono molto agli scrittori di razza. Non perché s'innamorano delle cose strane o dei termini ricercati, ma perché sentono - con una percezione quasi fisica - che in quelle parole si celano secoli e millenni di esperienza umana. Ma accade che le parole, quelle più dense di significato, scompaiano dalla scena pubblica, dal linguaggio comune, ed entrino in una sfera per palati sensibili al sapore intenso che spesso hanno queste parole. Per esempio: Ipotiposi. Questo libro di Mario Porro è un omaggio a Carlo Emilio Gadda che dell'ipotiposi ha fatto un emblema del suo stile. Un pensare per immagini che Italo Calvino chiamò "dubitosa sapienza". E non ha spazio solo in letteratura l'ipotiposi ma anche nella scienza e la filosofia... Una serie di saggi anticipati sulla rivista "Doppiozero" trovano in questo libro la loro naturale coronazione. La figura retorica dell'ipotiposi consiste nel rappresentare in modo vivido e immediato un oggetto, un gesto o una situazione: la forza plastica della descrizione ri sveglia nell'animo di chi ascolta visiones, phantasiae, rende presente agli occhi quel che la parola esprime, quasi mettendolo in scena. I capitoli del libro costituiscono una sorta di vagabondaggio fra le metafore che si rincorrono nella storia del pensiero. Il libro è l'esito di scorribande nella storia delle scienze naturali ed umane, fra le pagine della letteratura e nelle arti figurative. Seguendo l'invito alla filosofia di Michel Serres: praticare l'erranza fra i saperi, percorrere gli spazi dove transita Ermes, dio degli incroci e delle ibridazioni. Le ipotiposi qui schizzate - la rete e la nuvola, l'acqua e l'ombra, il mare e la foresta - sono le cose stesse a cui dobbiamo tornare per cercare di comprendere quell'oggetto-soggetto che è il mondo.
Breton. Lo sciamano della poesia
Libro: Copertina morbida
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2019
pagine: 138
«Il neonato piangeva nella sua culla e il padre disse: "Mi ricordo di Babilonia". Poi la madre lo coricò in una piccola vettura trainata da un leone e una vergine nuda. Era il 18 febbraio 1896, e tutti compresero che non bisogna risalire fino al gesto confondente. Mentre leggeva Baudelaire, Huysmans, Mallarmé e Barrès, una folla di donne-tronco molto belle, con una lumaca sulla testa, lo contemplava a mani giunte. Fu allora, nel 1913, che conobbe Paul Valéry, perché il regno del linguaggio esige la più grande agitazione. A volte i serpenti portavano cappelli a cilindro, le gigantesche cicale si sedevano in poltrone rotonde, un'aquila leggeva la "Divina Commedia". Il poeta, mobilitato nel 1915, era stato assegnato a un centro di neuropsichiatria. Ma i serpenti, le cicale e le aquile sanno che il sogno è di un'innocenza selvaggia. L'inventore ha due scale di ferro che fanno comunicare la gola con il cervello, Sarah Bernhardt ha il volto coperto di nature morte impressioniste, e il poeta (che, nel 1919, pubblica il suo primo libro, "Mont de Piété") ha la parola "speranza" scritta sulle dita. Freud, Aragon, Ernst, Tzara, Soupault, Desnos, Picabia, gli amici del poeta danzarono al Ballo degli Incoerenti con delle vedove bianche e nere, con le Preziose di Abraham Fosse e le lascive sonnambule, mentre la bella e la bestia giocavano a sodomizzarsi. È nel 1924 che esplode il "Manifesto del Surrealismo", nell'avenue de Raymond Roussel, nell'inverno di Arcimboldo, nelle matematiche di Lewis Carroll, nei viaggi fantastici di Goya, nelle immagini della confusione di Rimbaud, nei seni eretti di tutte le donne e negli indomani che cantano. Chi non ha visto Nadja, nel 1928, scivolando sui pattini, una torcia in mano, rivelare a Dracula, Don Chisciotte e Casanova il segreto dell'assurdo? (...) Il poeta viaggiò e percorse così i mille meandri dietro lo specchio, le follie e i fantasmi, nudo, a cavallo di una vacca dalle corna dorate, portando sulla testa una colomba bianca. Lontano, nella sfera, gli innamorati si abbracciavano, a testa in giù. Dall'"Ode à Charles Fourier" al "Surréalisme, méme" e "La Brèche", il poeta vide, tra altre innumerevoli meraviglie, la donna sorgere, adulta, dalla breccia aperta a colpi d'ascia nel cranio di un vegliardo dalla barba bianca e dagli enigmi a forma di automobile marciante a tutto gas. E nel 1966 il poeta morì senza morire».(Arrabal)
L'anima di Napoleone
Léon Bloy
Libro: Copertina rigida
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2019
pagine: 127
«Non si tratta di un'ennesima vita di Napoleone - scrive Gennaro Auletta nell'introduzione -. E neppure di un'interpretazione del "caso Napoleone" secondo criteri di contingenza politica, sociale, militare, psicologica o che so altro. Bloy non è uno storico, nella comune accezione del termine; gli manca assolutamente la capacità di immergersi nel relativo e di cercarvi le cause o le concomitanze. "Non solo non sono uno storico, ma ignoro la storia. Bisogna vedere in me una specie di sognatore, di visionario, se vi piace, ma niente più", scriveva a Jean de La Laurencie il 31 agosto 1913; e questo perché "sarebbe un errore gravissimo e funestissimo credere che io sia un pensatore, un intellettuale. Io conosco in realtà poche cose e ho capito soltanto quello che Dio m'ha fatto capire quando mi son fatto simile a un bambino" (Lettera alla fidanzata, 31 ottobre 1889). Bloy sta sempre dalla parte dell'Assoluto, guarda le cose e gli uomini sub specie aeternitatis, e sotto questo aspetto può essere considerato benissimo come un originale, anche se non sempre accettabile, esegeta della storia, che possiede una sua filosofia o meglio teologia della storia». Ma questa edizione dell'Anima di Napoleone, che appartiene ai testi più visionari del grande scrittore cattolico francese e arriva a fare del Bonaparte "la Faccia di Dio nelle tenebre", ha dalla sua il cimento, ormai ottant'anni fa, nel 1939, di un grande autore italiano oggi forse misconosciuto, Domenico Giuliotti, che curò la traduzione del libro e scrisse per l'occasione un saggio e una "nota biografica" cariche d'ispirazione. Possiamo dire che su queste pagine si sono incontrate le voci di un profeta apocalittico e di un poeta amante della parola scabra e arcaica, accomunati dal sentimento intransigente di un cattolicesimo difeso fino all'ultima stilla di sangue ma senza passatismi, anzi attraverso una contundente e moderna plasticità della parola che testimonia la forza di idee e convinzione di entrambi.
Il dossier «Bagatelle». La polemica su Céline in Francia e in Italia
Libro: Libro rilegato
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2019
pagine: 154
Libro di infinita ed esasperata rabbia nei confronti degli ebrei, "Bagatelle per un massacro" (1938) sollevò in Francia critiche ed entusiasmi, che questo libro documenta nei passaggi più rilevanti. Qualche anno dopo l'atroce constatazione: ciò che Céline augurava agli ebrei si era puntualmente verificato nella Germania nazista. Letti retrospettivamente le "Bagatelle" e le reazioni dei critici segnano un passaggio decisivo nella cultura francese. Céline riassume in quel velenoso pamphlet secoli di pregiudizio antisemita proiettandolo nello spazio di un potente immaginario polemico, in realtà utilizzabile, e in parte utilizzato, all'occorrenza per qualsiasi causa. Molti, a sinistra, pensavano, dopo "Viaggio al termine della notte" (1932), di poter piegare la forza del linguaggio di questo scrittore ai propri fini politici. Con "Bagatelle" la delusione e il rammarico. Ma anche a destra l'appoggio al pamphlet è sempre accompagnato da distinguo e puntualizzazioni. La sua forza espressiva deve essere confinata a una funzione retorica, gli argomenti contro gli ebrei dovevano avere ben altro sostegno. Eppure, la storia della Shoah ha testimoniato che tutti quei distinguo non valevano nulla di fronte alla realtà dello sterminio nazista. Di "Bagatelle" se ne torna a parlare in Italia nel 1981, quando l'immagine dello scrittore ormai riconosciuto tra i più importanti per stile e linguaggio, si completa con la traduzione dell'urticante pamphlet. Quasi dimenticato in Francia, non viene accolto nei volumi della collezione Pléiade (anche per volontà della vedova di Céline, che non vuole fomentare l'odio verso di lui), l'editore Guanda lo traduce integralmente dopo la prima edizione del 1938, ampiamente censurata dal fascismo. Un dibattito, breve ma intenso, ridisegna i confini di ciò che è permesso e ciò che è proibito. Un anticipo sostanzioso di quello che si andava definendo come politically correct.
L'ultima leggenda di Caino
Miguel de Unamuno
Libro: Copertina morbida
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2018
pagine: 131
«Unamuno plasma come argilla la storia di Caino e Abele - scrive Alessandro Rivali nella Prefazione -, mischiando i loro lineamenti e interrogandosi sulle zone lasciate in ombra dalla scarna e così potente narrazione biblica. Chi era davvero Abele? Chi Caino? Lo scrittore spagnolo indaga il tarlo che spolpò le esistenze dei due fratelli, che chiuse anzitempo gli occhi all'uno, che marchiò la vita dell'altro, costretto a un'esistenza di deserti e solitudini: sempre in fuga, bruciato dall'esilio, senza la possibilità di relazioni autentiche. I fratelli divisi: un tarlo che ha interrogato classici vicini e lontani, da Eteocle e Polinice fino al partigiano Kyra e al suo fratello maggiore, ufficiale fascista, raccontati da Beppe Fenoglio nell'epopea del Partigiano Johnny. Lo sguardo di Unamuno è di ossidiana, nero e lucente. Vuole comprendere il male, l'origine della discordia e, quindi, la natura dell'invidia. Ecco allora rinascere il dramma dei due amici fraterni, Abele Sànchez e Joaquin Monegro, in un'ipotetica Spagna di primo Novecento. Abele Sànchez è l'"eletto". Il primo della classe, distante quanto antipatico nella sua perfezione, lontano dal pastore in qualche modo zuccheroso del nostro immaginario. Abele è un pittore di talento. È "ambizioso di fama, di gloria, di notorietà". Crea personaggi così intensi che sembrano veri. Come nell'antichità l'uva dipinta da Zeusi che ingannava gli uccelli che scendevano a lacerare le sue tele. Con la sua arte, Abele sembra capace di risuscitare i morti, di farli uscire dall'intelaiatura delle cornici. Abele è bello, ma non buono. Soffia la vita nei quadri, ma non ha specchi per esaminare la propria anima. È un narciso senza rimedio. Gli altri uomini per lui sono comparse sbiadite, scalini da superare. Le donne, poi, trofei da collezione. Almeno fino all'incontro con la bellissima e sfuggente Elena, che lo porterà a un tragico lento destino...».
Kafka umorista
Guido Crespi
Libro: Copertina morbida
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2018
pagine: 138
L'analisi della comicità in Kafka di Guido Crespi ha una carica innovativa rispetto all'interpretazione che di Kafka vede solamente l'artefice di un'opera che contestava dall'interno le ragioni che rendono possibile il totalitarismo. È evidente, come scrisse Kundera nei "Testamenti traditi" che lo scrittore, lungi dall'essere alienato dal suo riso, in realtà "si diverte per noi" mentre inscena le sue storie condendole con crudeltà e sadismo, tanto più notevoli perché serviti freddi con una prosa al tempo stesso allusiva e trasparente (in apparenza, ma sempre con la doppia camera di compensazione del "simbolo nascosto"). David Foster Wallace nel 2005 scrisse che "la comicità di Kafka dipende da una sorta di letterarizzazione radicale di verità solitamente trattate come metafore" dispiacendosi di non essere capace di far comprendere ai propri studenti "che Kafka è comico". Il maggior studioso contemporaneo dello scrittore boemo, Reiner Stach, si è voluto concedere alla fine del monumentale lavoro biografico durato circa vent'anni, un libro propriamente "kafkiano", ovvero composto con "99 reperti" che ci offrono tutti insieme i tratti somatici dell'Uomo-Metamorfosi. Eccone alcuni: "Kafka bara all'esame di maturità", "Kafka s'infuria", "Kafka vorrebbe essere come Voltaire", "Kafka e Brod perdono al gioco i soldi della cassa comune per il viaggio". Il ritratto che ne esce, dove si mettono a nudo i tic di un uomo apparentemente come altri, ma che delle sue ossessioni - compresa quella sessuale, su cui il comico di Kafka si sbizzarrisce non poco (la sua Brunelda era rimasta nel cuore di Fellini, anche se non riuscì a farci il film che avrebbe desiderato, all'incrocio fra la Gradisca e la Grosse Margot) - ha saputo darci il succo più puro e per questo anche il più pericoloso, è a tutti gli effetti una maschera da Commedia dell'arte e non è da escludere che la figura longilinea di Kafka, i suoi tratti minuti e appuntiti del volto, possa trasformarsi nel burattino del ventriloquo, in perfetto abito di gala, che apre e chiude la sua bocca per pronunciare battute franche e crudeli a cui si dà ascolto come un divertimento ma che arrivano a toccare i nostri più nascosti orgogli. Come il saggio di Crespi dimostra. Prefazione di Alessandro Paci.
I morti. Discorso sulle tre guerre mondiali
Günther Anders
Libro: Copertina morbida
editore: Medusa Edizioni
anno edizione: 2018
pagine: 102
Se prima alla "teoria dei giochi" alla base dell'equilibrio del terrore (la famosa MAD, Mutually Assured Descruction) era assicurata una sua validità in quanto i giocatori erano due, poi tre (la Cina, cosa che Anders non manca di registrare), oggi la dissuasione nucleare è un gioco che forse non ha neppure un tavolo, tanti sono gli attori che di volta in volta postano sul tappeto verde le loro fiche. Se questo è vero, lo è anche e ancor più il motivo per cui queste pagine sono state scritte e Günther Anders ha speso la maggior parte delle sue risorse intellettuali e morali e la sua intelligenza, vale a dire il pensiero che le società nuclearizzate sono vulnerabili in una modalità e con pericoli che minano alla radice la possibilità stessa dell'esistenza umana in quanto tale. Le pagine di Anders qui pubblicate rappresentano un buon prò memoria a uso delle giovani generazioni su quanto sia importante non solo mantenere alta l'attenzione sui fenomeni di proliferazione dell'armamento nucleare ma, soprattutto, sull'evolvere e mutare del loro significato. E dal momento che il pensiero del filosofo tedesco ha per oggetto l'uso della filosofia per evitare la catastrofe, quindi con un forte appello all'azione, è altrettanto evidente che si tratta per il presente di riattivare le risorse morali capaci almeno di indicare la natura della minaccia che incombe. Oggi questo indicare è pressoché scomparso. E queste pagine possono essere ancora motivo di riflessione per riattivarlo. Seguito da "Una prefazione a Hiroshima è dappertutto". In appendice testi di Karl Jaspers, Maurice Blanchot, André Glucksmann e John Rawls.