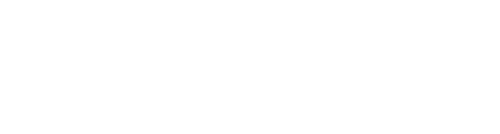Salerno Editrice: Studi e saggi
Le impronte del socco. Saggio sul teatro comico di Alfieri
Giuseppe Andrea Liberti
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2023
pagine: 200
Sul finire dell’Epoca Terza della Vita, Vittorio Alfieri scrive di aver fatto il suo « burlesco ingresso in Parnasso col socco e coturno ad un tempo ». Erano state infatti una tragedia e una commedia a essa legata, rispettivamente l’Antonio e Cleopatra e I poeti, a sancire l’inizio di una parabola che avrebbe portato alla stesura di alcune delle maggiori tragedie della tradizione letteraria italiana come di una serie di trattati di rilevanza europea. Al genere commedia, però, Alfieri sarebbe tornato solo in tarda età, portando a parziale compimento un progetto a lungo ponderato di sei Commedie, dissacranti nei riguardi delle manifestazioni del potere (L’Uno, I Pochi, I Troppi) come della decadenza morale e dei costumi (La Finestrina, Il Divorzio) e non di meno ancora capaci di proposte costruttive sui piani dell’etica e della politica (L’Antidoto). Ma che cosa rappresenta, all’interno del sistema letterario alfieriano, il nuovo approdo alla commedia? E quali sono le sue caratteristiche? Questo libro intende seguire le orme che Alfieri lascia col suo socco, la calzatura propria degli antichi attori comici, offrendo una sintesi interpretativa di queste ultime frecce scagliate contro gli inediti, grotteschi volti della tirannide: pertanto, il lavoro traccia un profilo storico e ideologico delle sei Commedie, analizzandone le specifiche formali e rilevando i legami che intrattengono con le precedenti esperienze comiche dell’autore. Incrociando intenzioni satiriche, riflessione sul teatro e proposta politica, si percorrono le molteplici vie della commedia alfieriana, considerata non come l’esito mediocre di uno scrittore che ha esaurito l’ispirazione, né lo sfogatoio di un reazionario incattivito, bensí in quanto contributo alla sperimentazione sulle forme del riso di un drammaturgo che critica il suo tempo ma che, guardandosi allo specchio, riesce anche a ironizzare sulle sue contraddizioni e ossessioni.
Le forme del racconto. Tre percorsi del poema in ottave tra XVI e XVIII secolo
Luca Ferraro
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2023
pagine: 220
Il presente volume è il risultato di dieci anni di studi sulla tradizione del poema in ottave in Italia. È composto da nove saggi suddivisi in tre percorsi. Il primo si incentra sulla creazione del genere eroicomico da parte di Alessandro Tassoni, con studi sulla Secchia rapita e sull’Oceano. Il secondo affronta tre questioni attraverso l’analisi di altrettanti poemi pubblicati tra XVI e XVII secolo: la traduzione di un’opera di età classica in ottava rima, il racconto odeporico, e il rispetto del verosimile rispettivamente ne La battaglia de i topi e delle rane di Lodovico Dolce, ne La vittoria della Lega di Tommaso Costo e nella Roccella espugnata di Francesco Bracciolini. L’ultimo percorso si occupa della fondazione e dello sviluppo di una tradizione di poemi in ottave in napoletano tra XVII e XVIII secolo, analizzando alcuni casi di studio: tre opere di Giulio Cesare Cortese, la traduzione della Batracomiomachia di Nunziante Pagano e quella della Gerusalemme liberata di Gabriele Fasano. Alcuni temi di ricerca sono toccati in più parti del volume, come i caratteri della poesia eroicomica, le soluzioni approntate per la traduzione di un classico, il rispetto del verosimile, la gestione del modello dell’Odissea nel poema di viaggio. Il trait-d’union trasversale a tutti gli studi è il riuso dei modelli ariostesco e tassiano in poemi distanti tra loro per cronologia, luogo di produzione, intenti, codice linguistico e registro stilistico usati. Il risultato è una sorta di geografia e storia della tradizione minore del genere epico-cavalleresco ed eroicomico italiano, che si muove tra Modena, Roma, Venezia e Napoli, tra gli anni ’70 del Cinquecento e la metà del Settecento.
L'invenzione della Repubblica. Storia e politica a Firenze (XV-XVI secolo)
Andrea Salvo Rossi
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2022
pagine: 176
I saggi raccolti in questo volume analizzano l’intreccio tra scrittura della storia e discorso politico a Firenze tra Quattro e Cinquecento, conseguente alla rifondazione retorica del sapere promossa dall’Umanesimo. Solo concependo la storiografia come una pratica autoriale – che non si limita a raccogliere dati, ma li seleziona e li interpreta – fu possibile riorganizzare le forme di razionalizzazione e legittimazione della vita civile su basi storiche. Le origini romane della repubblica fiorentina diventarono così il punto di appoggio per strategie molteplici di intervento nel presente politico di Firenze, riletto analogicamente alla luce del passato di Roma. Il percorso proposto, che parte da Leonardo Bruni per arrivare al definitivo tramonto delle sperimentazioni repubblicane con l’avvento del Granducato, mostra efficacemente come l’idea che il sapere politico fosse indissociabile da quello storico consentisse di veicolare allo stesso tempo elementi di continuità e discontinuità nelle forme di autorappresentazione (e autopromozione) delle istituzioni fiorentine. Continuità nel riuso delle fonti come elemento strutturante della riflessione politica; discontinuità nei movimenti sul canone degli Antichi per dar conto di movimenti della vita istituzionale, delle crisi e dei mutamenti di stato che caratterizzarono la parabola repubblicana di Firenze. Ne emerge un quadro di grande stabilità nell’intendere le antiche historiae come linguaggio eminente della politica. Anche di fronte alle svolte e alle fratture con cui dovette fare i conti la generazione di autori che si trovò a scrivere le storie fiorentine negli anni delle guerre d’Italia (da Rucellai a Nardi, passando per i più celebri Machiavelli e Guicciardini) è possibile registrare una sostanziale tenuta metodologica, ancora ben visibile nella tradizione tardo-rinascimentale, tipicamente fiorentina e toscana, del tacitismo politico.
Il tempo diviso. Poesia e guerra in Sereni, Fortini, Caproni, Luzi
Bernardo De Luca
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2022
pagine: 118
All'indomani del secondo conflitto mondiale, Vittorio Sereni, Franco Fortini, Giorgio Caproni e Mario Luzi provarono a restituire nei loro versi le conseguenze del trauma di massa per eccellenza, la guerra. Nati tra il 1912 e il 1917, questi quattro poeti trascorsero la “giovinezza” durante il Ventennio fascista; il passaggio alla maturità coincise, quindi, con lo choc bellico. Tre di loro furono direttamente coinvolti e chiamati alle armi: Sereni, Fortini e Caproni. Ma il '43 rappresentò uno spartiacque per tutti: con l'arrivo degli Alleati, Sereni fu catturato in Sicilia e deportato nei campi di prigionia in Algeria e Marocco; Fortini fuggì in Svizzera e partecipò alla breve esperienza della resistenza con la Repubblica dell'Ossola; Caproni trascorse i diciannove mesi dell'Italia divisa partecipando alla resistenza in Val Trebbia. Luzi fu invece riformato per insufficienza toracica, ma durante i bombardamenti che colpirono Firenze la sua casa venne completamente distrutta e scontò anche lui direttamente i devastanti effetti del conflitto. I quattro giovani videro la propria biografia spezzata dalla guerra, un evento che non solo agì sull'esperienza vissuta ma determinò la loro fisionomia culturale, intellettuale e poetica: il tempo stesso appariva ormai diviso, rotto, “inceppato”, come dirà Sereni. Ecco perché nei libri di poesia che concepirono nel dopoguerra la frattura temporale causata dalla ferita bellica sembra raggiungere il passato, fino a torcerlo; ma mentre in Sereni, Caproni e Luzi, la possibilità del racconto viene del tutto a mancare, nella poesia di Fortini lo strappo traumatico si ricuce dentro una storia nuova. Non più da ricostruire, ma da cominciare a scrivere, in vista di un tempo “altro”. Il presente diventa attesa, proprio come il passato, che nella poesia impetra l'avvenire.
Il «Morgante», l'«Orlando» laurenziano e Andrea da Barberino
Paolo Orvieto
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2022
pagine: 276
Prosegue con questo volume lo studio che Paolo Orvieto sta conducendo da piú anni sul Morgante e sui poemi cavallereschi, di cui una “puntata” importante è stata la recente Lettura allegorica del ‘Morgante’, pubblicata nella stessa collana nel 2020. L’autore propone in queste pagine un capillare confronto tra il Morgante e l’Orlando laurenziano, grazie al quale dimostra come siano nel complesso deboli le argomentazioni addotte da Pio Rajna sulla priorità dell’Orlando: numerose e inconfutabili sono invece le prove secondo cui l’Orlando è soltanto un pessimo rifacimento del Morgante. Ciò confermerebbe l’origine “nobile” e non popolare, come sosteneva Rajna, della nostra letteratura cavalleresca. Si indicano perciò nelle opere del “maestro” Andrea da Barberino (che Orvieto ritiene in altri saggi assai piú numerose di quelle tradizionalmente a lui attribuite: si vedano Le ‘Storie’ di Rinaldo da Montalbano, del 2020; Le ‘Storie’ di Andrea da Barberino, del 2020; Le ‘Storie’ di Uggieri il Danese italiano, del 2021) l’inesauribile riserva da cui attingono i poemi cavallereschi del ’400, e in particolare Luigi Pulci. Il saggio ripercorre anche le piú tipiche tecniche canterine (gli exordia proemiali non solo nei poemi e cantari, la captatio benevolentiae, il frazionamento in ben calibrate puntate, ecc.) e alcuni dei piú abusati tòpoi cavallereschi: la lotta del serpente/dragone col leone, la descrizione del padiglione, le favole. Si analizzano infine i canterini del Morgante (Lattanzio e Alcuino), avanzando di nuovo l’ipotesi che Antonio di Guido, il piú celebre cantimpanca di Firenze del XV secolo, sia l’autore dell’Orlando e che Pulci stesso si sia esibito nella piazza di San Martino, riservata alle esibizioni canterine.
Forme e figure della saggistica di Calvino
Sergio Bozzola
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2021
pagine: 200
Di Italo Calvino (1923-1985) sono sempre state approfondite, discusse, analizzate le forme narrative della sua prolifica attività di scrittore. L'interesse degli studiosi si è invece solo saltuariamente soffermato sulla sua attività critica. Oggetto di questo volume è proprio la scrittura saggistica di Calvino, da Una pietra sopra (1980, ma con testi che vanno dal 1955 alla fine degli anni Settanta) a Collezione di sabbia (1984), fino alle postume Lezioni americane, ovvero le tre raccolte di saggi composte direttamente o indirettamente dall'autore stesso e dunque pensate come insiemi. A partire da uno spoglio ampio e sistematico della lingua e dello stile calviniani (come a tutt'oggi ancora non è stato fatto al di fuori del dominio narrativo), sono esaminati l'organizzazione del macrotesto, i modi di costruzione dei singoli saggi, le forme dell'argomentazione, i fenomeni di incrocio e contaminazione di generi e tipologie testuali (emersioni narrative nella scrittura saggistica, funzione delle descrizioni, dialoghi, ecc.); quindi, in un progressivo dettagliamento della prospettiva, le figure dell'elocutio (come la ripetizione e l'accumulazione), le metafore critiche e il linguaggio figurato. Fenomeni e forme vengono collocati entro la cornice di un "primo" e di un "secondo" Calvino, prima, durante e dopo il cambiamento che coinvolge la sua intera esperienza intellettuale e letteraria lungo gli anni Sessanta del Novecento: dalle posizioni piú ideologiche e agonistiche del primo decennio postbellico, all'atteggiamento scettico e alla postura appartata che caratterizzeranno narrativa e saggismo fino alle Lezioni americane.
Scritti su Leopardi
Francesco Paolo Botti
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2021
pagine: 160
Gli studi raccolti in questo volume, composti nell'arco di quasi un ventennio, disegnano un ventaglio variegato di occasioni critiche. Ma, a ricondurre la specificità delle singole analisi a una - seppur inevitabilmente relativa - compattezza monografica provvede la coerenza dei loro esiti interpretativi, tutti convergenti nel mettere in rilievo, in vari oggetti e da varie prospettive, la cesura profondissima che la produzione leopardiana opera all'interno di una secolare tradizione poetica e culturale. Sia che affronti, in maniera radicale, tematiche supreme come il dolore o la felicità, sia che rimoduli una figura cruciale della scrittura letteraria come l'ossimoro, a cui conferisce un nuovo e inconfondibile spessore ideologico, sia che dal cuore stesso della sua educazione classicistica liberi le cadenze assolute della lirica moderna, esperienza separata, diversa dalla precedente, sia che testimoni nella commistione di stili delle "Operette morali" l'impossibilità del tragico nel mondo contemporaneo, la parola di Leopardi, del poeta-filosofo, risuona sempre con l'intensità rivoluzionaria e preveggente che ne fa il primo, grande classico italiano della modernità.
Il Livio di Machiavelli. L'uso politico delle fonti
Andrea Salvo Rossi
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2021
pagine: 292
Troppo disorganici per essere un trattato politico, troppo frammentari per essere un'opera storica, i Discorsi mettono da sempre a disagio chi voglia inquadrarne il genere. Inoltre, l'impossibilità di risalire al manoscritto di Livio presente sullo scrittoio di Machiavelli ha reso piú complicata la definizione di un puntuale confronto tra i due, spesso risolto in piú generali riflessioni su Machiavelli e la storia antica. Le decadi liviane non sono, però, una fonte tra le altre dell'elaborazione machiavelliana, ma rappresentano il terreno decisivo per la definizione di un metodo che tiene costantemente insieme politica e storia («lunga esperienza delle cose moderne» e «continua lezione delle antiche»). Con questa convinzione, il presente studio ricostruisce le vicende che — nel solco dell'Umanesimo — avevano imposto la canonizzazione degli Ab urbe condita, cosí da restituire l'orizzonte entro il quale era maturata la lettura di Machiavelli, fornendo poi di questa un'analisi tipologica attraverso l'esame di citazioni, traduzioni e riscritture. Le puntuali indagini sul testo consentono di mettere a fuoco gli strumenti con cui l'autore dei Discorsi, inserendosi in una tradizione consolidata (quella che faceva di Roma la misura di ogni tempo storico), prova a fare i conti con la radicale, tragica novità rappresentata dalle Guerre d'Italia. Se la frattura con il passato è irrisarcibile, non basta piú conoscere la storia antica per capire quella contemporanea: Machiavelli, dunque, forza i testi che legge perché rispondano alle sollecitazioni imposte dalle urgenze del presente, tramite quello che qui si propone di chiamare "uso politico delle fonti".
Attraverso il Novecento. Studi e interpretazioni
Giuseppe Nicoletti
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2020
pagine: 220
Se un elemento distintivo può essere intravisto in questa raccolta di studi novecenteschi esso risiede nella proposta e quindi nella descrizione di episodi di “sociabilità” intellettuale di cui il secolo ormai trascorso è stato testimone forse assai più di ogni altro fino ad oggi. Nel segno e sotto l’egida della migliore letteratura e della critica più intelligente e penetrante, studiosi del giure come Piero Calamandrei, artisti figurativi come Italo Cremona, musicisti come Luigi Dallapiccola e intellettuali in genere si sono sentiti spesso attratti e partecipi di un clima e talvolta perfino di un progetto che metteva in relazione la propria, specifica disciplina o arte con la scrittura letteraria, nonché con i modi di aggregazione che i letterati hanno posto in essere in questo stesso secolo al fine di promuovere e dare un senso alla propria presenza nella società. Nel volume, pertanto, possono trovarsi esemplificati o soltanto richiamati esempi non poco significativi di tali forme di integrazione fra le arti e i saperi e, in una con questi esempi, compaiono letture critiche più mirate e circostanziate su opere di scrittori del secondo Novecento (Calvino e Volponi). Nella seconda parte del libro, insieme con uno studio su un periodico futurista della seconda “ondata” come « L’Italia futurista », indagata nei suoi rapporti con il surrealismo francese, vengono rivisitate criticamente opere e personalità di una tradizione letteraria che ha visto Firenze nei primi decenni del Novecento al centro dell’interesse nazionale: sono prese in esame opere ampiamente accreditate dai canoni correnti della storiografia più aggiornata come Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, così come titoli restati stranamente ai margini della ricerca e delle analisi di critici e studiosi ed è il caso dei Racconti lontani di Alessandro Bonsanti.
Povertà. Atti del sesto Colloquio internazionale di Letteratura italiana, Napoli, 27-29 maggio 2015
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2020
pagine: 459
Gli Atti contenuti in questo volume fanno parte di un progetto di ricerca sulla storia delle parole nella nostra tradizione letteraria, avviato nel 2004 presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nei Colloqui si pone al centro dell'attenzione un lemma significativo trascelto nell'ampio corpus della letteratura italiana. I cinque precedenti appuntamenti furono dedicati a illusione, ordine, silenzio, unità, fortuna; il sesto Colloquio, tenuto a Napoli nei giorni 27-29 maggio 2015, è stato intitolato alla povertà. Il metodo d'indagine è rimasto lo stesso adottato nei precedenti incontri: risalire all'uso e alle accezioni del vocabolo dal mondo antico fino a noi, privilegiando lo scandaglio della tradizione letteraria italiana e il suo dialogo con discipline e forme d'arte diverse (dal diritto alla sociologia, dalla musica al cinema), non solo europee. Attraverso la voce di venti studiosi, è stata così restituita l'inedita, originale narrazione della parola e dei contesti che l'hanno nominata: dalle Beatitudini a san Francesco, da Petrarca ad Alberti, da Machiavelli a Tasso fino al Lazarillo de Tormes e a Giulio Cesare Croce. Inoltre il lemma povertà è stato analizzato in Pagano, Leopardi, Verdi, Pascoli, Verga; un termine che poi, nel Novecento, si impone nella poesia, nella narrativa e nel cinema: dai crepuscolari a Ungaretti, da Capitini a Luzi, Betocchi, Turoldo, Scotellaro, Pasolini, Zavattini, da Bilenchi a Madieri e in maniera particolarmente rilevante nella testimonianza religiosa, come mostra il saggio sul teologo Arturo Paoli, e nella riflessione filosofica e giuridica. Se nell'arco di secoli di vita del nostro idioma il dibattito sulla povertà appare minoritario e di fatto è rimasto fino alla metà circa del XX secolo un argomento poco presente alle culture dominanti, dalla lettura del libro emerge la ricchezza di interpretazioni di una parola che ci attraversa, che per aspetti diversi ha sollecitato le varie forme dell'arte e sta misurando la storia della nostra civiltà.
Lettura allegorica del Morgante
Paolo Orvieto
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2020
pagine: 220
Il saggio completa altri due studi sul Morgante di Pulci pubblicati da Paolo Orvieto per la Salerno Editrice: "Pulci medievale" (1978) e la monografia "Pulci" (2017). L'attenzione è concentrata soprattutto, ma non solamente, sugli ultimi quattro cantari del Morgante, in cui, per ragioni culturali e esistenziali, Luigi Pulci cerca, da un lato, di scardinare l'establishment culturale ficiniano, con la protratta e infamante traduzione allegorica di Marsilio Ficino, alias Marsilio re saraceno, e l'ulteriore identificazione del filosofo con il mago Malagigi, colpevole, appunto come Filino, di praticare una magia demoniaca. Dall'altro lato Pulci mette in scena un alter ego, Astarotte, che è ora un coltissimo teologo cristiano, agostiniano e tomistico, vero restauratore della genuina fede cattolica contro l'ermetismo pagano di Ficino. Una compiuta denuncia anche dell'astrolatria ficiniana, per cui l'influenza astrale determinerebbe ogni accadimento terreno, negando quindi sia la prescienza divina sia il libero arbitrio dell'uomo. Una serie di tableaux vivants che non sono più solo dell'entourage carolingio, ma, insieme, trasferiti di peso dalla palpitante realtà fiorentina. Allegorie che si estendono a Lorenzo de' Medici e a Pallante (Piero figlio di Lorenzo) e Lattanzio (Pulci stesso, che si identifica anche con Orlando morituro a Roncisvalle); e che, pur d'altro genere, coinvolgono i primi ventitré cantati: si ribadisce con altri accertamenti quella tra Morgante e Margutte e Bernardo Bellincioni e Antonio di Guido, qui reputato anche il possibile autore e falsificatore dell'Orlando laurenziano. Infine una revisione delle ipotizzate allegorie "morali" dei primi cantari del Morgante: nient'affatto edificanti, bensì dissacrazioni, ai limiti della blasfemia, delle più diffuse allegorie teriomorfe del cristianesimo.
«Secolo che ci squarti... secolo che ci incanti». Studi sulla tradizione del moderno
Antonio Saccone
Libro: Libro in brossura
editore: Salerno Editrice
anno edizione: 2019
pagine: 296
Il libro esamina episodi cruciali della tradizione del moderno quale si è venuta configurando nel Novecento italiano. Al centro dell'indagine la Grande Guerra, l'intreccio tra letteratura e scienza, la fusione tra le arti, le nuove percezioni dello spazio e del tempo, il modo in cui importanti autori del 'secolo breve', commentando classici del passato remoto e prossimo, interrogano se stessi. Sul proscenio Comisso e la sua avventura fiumana, l'antibellicismo di Palazzeschi, i futuristi interessati a coniugare apocalisse e rigenerazione dell'arte, a celebrare l'instantaneità del cinema, a proclamare una scienza che amplifichi l'ignoto, ad intensificare la creatività dell'avanguardia attraverso le invenzioni dello "scugnizzo" Cangiullo. E poi Quasimodo che discute del dualismo tra politica e poesia, Domenico Rea e La Capria, severi interpreti di Eduardo, il Dante letto da Montale, il racconto-saggio di Sciascia sulla scomparsa dello scienziato Majorana, Calvino che analizza gli 'scienziati' della letteratura latina, Primo Levi narratore della chimica e Luzi che rideclina, attraverso un confronto con i suoi maiores, una prospettiva della modernità su «conquiste altissime» e «abissi spaventosi».